
Buchi, carotaggi, tagli profondi. Ho raccolto qualche idea per libri da fare, rispolverare, rifare e lucidare, che appoggio qui gratis et amore dei con la premessa forse scontata che son tutte lingue da cui traduco, quindi ci siamo capiti. Spunti copincollabili senza fatica, pur nel rispetto teorico della licenza Creative Commons spalmata su tutti i contenuti di questo blog.
Dal tedesco. Leggenda vuole, anzi storia certificata vuole che il primo Schwulfilm della DDR, Coming Out, per la regia di Heiner Carow, sia uscito la sera del 9 novembre 1989. Facile immaginarsi con quale successo di pubblico. Si sa meno che quello stesso anno uscì, sempre nei territori della Repubblica Democratica, un primo volumetto non fantascientifico né psicofarmacologico sull’omosessualità, ma proprio un libro che dava voce a tredici maschi gay cittadini tedeschi orientali. Si chiamava Ganz normal anders e a curarlo per Aufbau, senza metterci la propria voce né dichiararsi apertamente, fu Jürgen Lemke. Di suo ci sono la commovente dedica “Per Frank” a inizio foliazione e quattro righe a pagina 284 in cui ringrazia le persone intervistate e l’editor Helga Thron. Prefazione tra il nervoso e lo spiazzato di Irene Runge. Ganz normal anders è una strepitosa scatola nera sulla vita in Germania (Est) dalla seconda guerra mondiale in poi. Digiuno di qualsiasi scatto attivistico, ignaro sia dei film berlinoccidentali di Rosa von Praunheim, sia della Kleinstadtnovelle di Schernikau, il libro sembra la scena iniziale di 2001 col desiderio omosessuale al posto dell’utensile osseo. AIDS citata al volo da Bert a pagina 280, con un pizzico di sollievo dedicato alla sua relazione stabile con Rainer. Il tono cambia da intervista a intervista, si va dalle Tunten più sbracate e consapevolmente “capovolte” alle maschie nell’armadio che millantano bisessualità e altre scappatoie. Impagabile da questo punto di vista la conclusione del cinquantenne “R.”: “So, nun muß ich aber langsam los. Mein Zug wartet nicht. Kopfschmerzen habe ich auch von deiner vielen Fragerei. Und es gibt ein ganz falsches Bild von mir, wenn wir uns nur über Männer unterhalten”. Effetto straniamento e macchina del tempo assicurato. Un gioiello rimasto chiuso per decenni nella sua custodia crucca, tradotto solo in inglese nel 1991 – e in lettone.
Dall’inglese. William Friedkin è morto poche settimane fa. A Venezia è stato presentato il suo ultimo lavoro, The Caine Mutiny Court-Martial. Non è questa la sede per parlare dei suoi film, che meriterebbero orecchie su orecchie. Ma forse è questo il momento per farsi una sana overdose di video su youtube che lo vedono protagonista col suo umorismo caustico e la sua rara capacità di fare autoanalisi, spesso autocritica, passando senza colpo ferire dai grandi successi dei primi anni Settanta ai numerosi fallimenti successivi. Epocale la sua risposta a una domanda riguardante la lavorazione di quel capolavoro che è Cruising (1980): I don’t give a flying fuck into a rolling donut about what Pacino thinks. Esattamente dieci anni anni fa, per HarperCollins, è uscita la sua autobiografia, The Friedkin Connection, cinquecento pagine d’oro zecchino che ricostruiscono minuziosamente una delle carriere più incredibili e irripetibili nella storia del cinema americano. Il tomo copre cinquant’anni di film e documentari, fino a Killer Joe (2012), ergo mancano solo l’ultimissimo film e il suo home movie delirante su padre Amorth, che ha messo in difficoltà anche la mia profonda fede friedkiniana. Insomma, poco male, oltretutto come lettura è una goduria e ha una delle chiuse più sincere e devastanti che abbia mai letto, che riporto qui tanto non è uno spoiler: “I haven’t made my Citizen Kane, but there’s more work to do. I don’t know how much but I’m loving it. Perhaps I’ll fail again. Maybe next time I’ll fail better”.
Come si fa a non amare Terry Jones? Il Python tranquillo, quello che metteva d’accordo tutti, invitava la truppa a scrivere a casa sua e quando necessario, senza frizzi né lazzi, si metteva dietro la macchina da presa. Il secondo ad andarsene dopo Chapman, in seguito a un lungo declino cognitivo già ravvisabile durante gli show all’arena O2 nel 2014. Insieme al sodale Palin, Jones amava la goliardia made in Oxford, il Medioevo e le favole. Ne ha scritte un bel po’, e tra il 1990 e il 2002 è pure uscito con Mondadori. Una parentesi che inizia con Nicobobinus (trad. Laura Cangemi) e termina con Lo scudiero e il cavaliere (trad. Giovanni Luciani), entrambi con le magnifiche illustrazioni di Michael Foreman. In realtà quella dello scudiero è una vera e propria trilogia proseguita con The Lady and the Squire (2000) e The Tyrant and the Squire (2018), pubblicato due anni prima della sua morte e probabilmente affastellato a partire da appunti, spizzichi e mozzichi. Nel 2011 però Jones era ancora in piena forma, e diede alle stampe due chicche: la raccolta di racconti Evil Machines, edita via crowdfunding con marchio Unbound, e soprattutto l’esile ma esilarante Trouble on the Heath, una “quick read” di cento paginette a corpo grosso uscita per Accent Press al costo di una sterlina e novantanove. Ambientato nella zona di Londra dove viveva, col parco di Hampstead Heath a fare da sfondo e quasi da personaggio a sé, il libricino frulla cani piscioni, gangster russi e palazzinari in un concentrato tardo-pythoniano efficace e senza un filo di grasso. Non esplosivo come Mr. Creosote, ma a volte contagioso come le casalinghe sfrante interpretate da Terry.
Dal polacco. Letteratura ancora poco nota – soliti noti a parte – e perlustrata a fatica per paura del mondo slavo e dei picchi sconcertanti dell’anima nazionale, quella polacca è uno scrigno col doppio/triplo fondo che merita di spingersi oltre i reportage e i (sacrosanti) premi Nobel. Prendiamo Eliza Orzeszkowa, esponente di spicco del positivismo tardo ottocentesco e di quella che allora si chiama praca organiczna, lavoro organico, tesa al graduale ripristino della Polonia (sud)divisa. Qualche traccia del suo coevo Prus si rimedia sul mercato italofono, ma di lei si sono perse le tracce da esattamente sessant’anni, quando le edizioni Paoline e le del Grifo azzardarono la pubblicazione di un suo romanzetto di 75 pagine. Di tutt’altra levatura Nad Niemnem (1888, “sul fiume Niemen”), uno dei capisaldi della letteratura polacca, che andrebbe recuperato insieme al coevo Lalka (“la bambola”) di Prus. Peraltro, se la prende con la Russia zarista.
Ugualmente importante, e noto almeno tra i cinefili grazie alla trasposizione di Andrzej Wajda, è Popiół i diament (1948) di Jerzy Andrzejewski. Cenere e diamanti (1958) è il film-universo della cinematografia polacca, un concentrato di analisi storica, sociologica e realismo magico oltre la cortina di ferro che non ha perso un minimo della sua energia. Mi fregio, e consentitemi l’inciso nerd, di averlo ancora in videocassetta originale rimediata nell’armadietto del bookcrossing all’istituto di slavistica berlinese. Il romanzo ebbe una genesi travagliata. Uscito nel 1947 con un altro titolo (“Subito dopo la guerra”), pochi mesi dopo venne riscritto dall’autore per rispettare le linee guida del nuovo governo filosovietico, che Andrzejewski sosteneva almeno sul piano ideologico. Successive modifiche arrivarono alla spicciolata fino al 1954. Quindi non è un romanzo: sono almeno due, il primo tutto da disseppellire. Popiół i diament è lo specchio del caos in Polonia durante gli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, tra potenze in ascesa e gruppi clandestini. Ultimo avvistamento in Italia: anno 1961, editore Lerici, traduzione di Vera Petrelli.
Un genere in cui la Polonia ha sempre avuto fortuna grazie a Lem è stato la fantascienza di stampo sovietico, quindi più pensosa, tecnocratica, filosofica rispetto alla media dei volumetti Urania. Un genere inanellato alla perfezione da Tarkovskij negli anni Settanta, quando portò sullo schermo sia Solaris (1972), sia Stalker (1979), cioè Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Strugackij. Leggere Lem al giorno d’oggi non è facilissimo. Io c’ho provato con Solaris, che unisce intuizioni rapinose a impreviste cadute di stile, ad esempio la descrizione razzista di una donna nera che appare, “fantasma su Marte”, al protagonista. La forza di Lem si lascia riassumere dal titolo del suo ultimo romanzo, Fiasco, scritto nel 1986 per conto dell’editore tedesco Fischer, che gli staccò un lauto anticipo. L’umanità non ce la può fare. L’universo non è morto, anzi è vivo e intelligentissimo come l’oceano di Solaris, ma è anche indifferente, incomprensibile e intraducibile, con buona pace della fantascienza occidentale conquistadora e ottimista, vedi Arrival (2016) di Villeneuve. Ma non c’è solo Lem. Sul finire dei fatidici Settanta, in Polonia un romanzo di fantascienza divenne ancor più popolare: Robot (1973) di Adam Wiśnieski-Snerg, recentemente riproposto addirittura da Penguin in una collana di classici SF. Scritto in prima persona non si sa se da un automa o da un individuo, il romanzo è lineare e travolgente nel raccontare un viaggio tra macchinari steampunk, oceani di mercurio e società non lontane da quella, di lì a poco egemonica nell’immaginario collettivo, à la Blade Runner.
Dal francese. La storica Sophie Bessis (Tunisi, 1947) è “juivarabe”. Da sempre sulle barricate per i diritti delle donne nel Maghreb, ha pubblicato numerosi testi sui rapporti tra il Nord e il Sud del mondo ed è una delle pochissime autrici a occuparsi dell’identità ebraica all’interno del mondo arabo. Lo fa ad esempio nel pamphlet Je vous écris d’une autre rive – Lettre à Hannah Arendt (Elyzad, Tunisi 2021). Scritto durante i primi mesi di pandemia, il testo parte da una provocazione per affrontare un tema più ampio e stringente. Bessis lo fa da ebrea tunisina, femminista e amante del pensiero arendtiano, che mette in discussione in quanto di matrice eurocentrica. La tesi è che la materia culturale per un dialogo costruttivo esiste già, soffocata però da nazionalismi e letture manichee. “Cara Hannah Arendt, è stato l’anno scorso, in riva al mare, che ho deciso di scriverle”. Inizia così questo breve saggio che si rivolge all’intellettuale tedesca sull’onda dell’inesauribile risonanza dei suoi testi. “La follia, diceva il suo amico Albert Einstein, consiste nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. E se la nostra follia fosse dovuta al rifiuto dell’Altro?”. Citando un testo contenuto in Politica ebraica (Cronopio 2013), Bessis ricorda come Arendt stessa non veda altra soluzione “per i nazionalisti coerenti, che diventare razzisti”. Secondo l’autrice, il problema dell’impostazione arendtiana è la “negazione dell’esistenza degli ebrei arabi”, come si evince da un suo articolo del 1942, nonché la collocazione dell’intero bacino del Mediterraneo nella sfera d’influenza culturale europea. L’auspicio è che lo stato israeliano ritrovi la propria componente orientale rimossa, disinnescando in tal modo i conflitti che lo minacciano e fanno virare a destra le sue politiche. A patto, ovviamente, che anche il nazionalismo arabo si smussi. “Da troppo tempo gli arabi vogliono essere soli”. L’antidoto all’antigiudaismo arabo sta prima di tutto nella riscoperta di una dimensione cosmopolita. Il testo è strutturato come un’unica, lunga lettera ad Arendt, con un post-scriptum che riflette sul virus come acceleratore dei nazionalismi. Di Bessis esiste un solo libro in italiano, L’Occidente e gli altri. Storia di una supremazia, edito vent’anni fa dalle Edizioni Gruppo Abele. Forse è il caso di tornare con lo sguardo all’altra sponda.



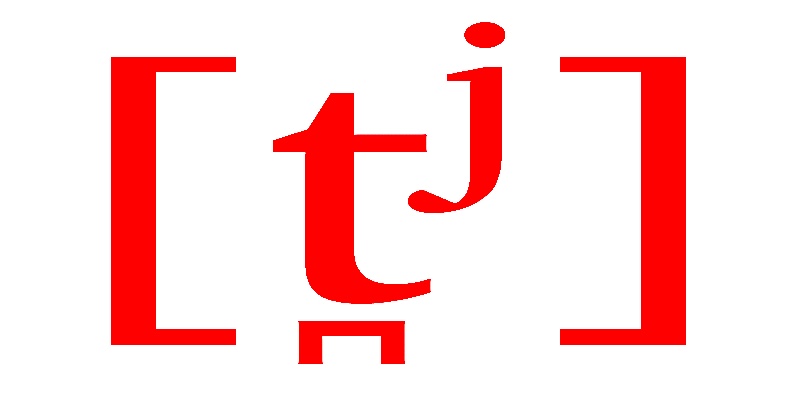
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.