
Quattro film dell’orrore, quindi del piacere puro, captati nell’arco di questo autunno tedesco inoltrato che sfocerà molto probabilmente in un inverno elettorale da Valpurga. E allora meglio allenarsi a esorcizzare ancora di più tramite schermo, grande questo schermo, visto in prima fila svaccati su qualche divano impresentabile, che solo a Berlino può fungere da sostituto della poltrona da cinema. Ultime frontiere selvagge di una città ormai normalizzata, piena come ai tempi di Weimar ma sempre meno acuminata e spiazzante. A quando un bel film tedesco neoespressionista che assorba e trasfiguri questo mulmiges Gefühl?
Terrifier 3 è un filmazzo americano. Attesissimo da almeno due anni, ha fatto notizia per l’ottimo risultato al botteghino malgrado la quantità immane di sangue e macelleria. Dei film precedenti di Damien Leone ho già parlato, e la visione di T3 è stata una gradevole sorpresa. Non solo Art the Clown è diventato un fenomeno di costume che piace anche ai bimbi, ma il film, solido e accessibile – per chi apprezza l’articolo – riesce su un livello inaspettato, che è quello dell’armonizzazione dell’immaginario. In altre parole, Leone mette ordine nel garage da serial killer in salopette dei titoli già usciti, portando avanti la trama verso un possibile finale coi fuochi d’artificio – e soprattutto, ricalibrando il tono. Le pecche, o i punti critici degli altri Terrifier vengono smussati con classe, potenziando le parti già efficaci. Qualche esempio senza spoiler. Se Terrifier 2 aveva espanso l’incubo del primo, concentrato in una sola notte, trasformandolo in un teen movie anni Ottanta con influssi fantasy e minutaggio fuori controllo, stavolta il film ha dei paletti. Riprende l’azione da dove l’abbiamo lasciata ma non con la precisione pedissequa del secondo: il rabbercio avviene in flashback dopo la sequenza iniziale, a sé stante, una classica home invasion. Visto che i protagonisti sono molto giovani, la sceneggiatura fa un salto di cinque anni a fini di credibilità, e la prima idea geniale è quella di mettere il mostro, e la sua collaboratrice, a riposo. In una palazzina che fonde il fetido col gotico. Per lo stesso motivo anagrafico, la bambina da tregenda che affianca Art nel secondo episodio scompare, sostituita da Vicky, in teoria avversaria del clown (così viene introdotta nel primo film – ma parlare di psicologia con demoni in forma di pagliacci è ridicolo, quindi l’incredulità va sospesa alla grandissima). Anche sul finale c’è una home invasion, che di fatto impedisce all’eroina Sienna (Lauren LaVera) di tornare nel luna park abbandonato del secondo film, con tanto di attrazione chiamata Terrifier. Un’ellissi che comprime l’azione, toglie alcune zeppe dalla trama e infila un bel tranello nella forma di un coprotagonista ammazzato fuori campo. Al contempo, si intuisce che il quarto capitolo avrà ben poco a che vedere con la concretezza urbana di scantinati, cessi, dormitori studenteschi e pizzerie da asporto. Stiamo ancora aspettando Machete nello spazio, ma forse vedremo Art agli inferi.
Il terzo lungometraggio targato Terrifier conferma la strategia autoriale del nome del regista piazzato col genitivo sassone sopra il titolo, un gimmick inventato da Carpenter ai tempi di Halloween e a sua volta mutuato da Hitchcock e Fellini. Il paragone può non reggere sul fronte della scrittura filmica – Leone ci mette del suo più negli effettacci che nei movimenti di macchina – ma è vero che l’invenzione di Art e la modellazione di questa epopea slasher dimostrano un controllo, e una perseveranza premiata dai fan, rarissimi nel genere trucido. Pochi anni fa ci ha provato, senza successo, Rob Zombie, e proprio nella sua trilogia della Casa dei mille corpi troviamo un pagliaccio coi denti marci, l’imprenditore del pollo fritto Captain Spaulding (Sid Haig). Zombie non ha mai più ripetuto l’exploit del primo film, reboot ufficioso e malsano del Texas Chain Saw Massacre, e i suoi remake di Halloween sono quasi subito finiti nel mucchio. Leone sta puntando tutto sulla proprietà intellettuale della maschera che ha inventato, costruendoci attorno un mondo, e un intreccio, via via corretti e riarrangiati.
Art funziona prima di tutto grazie alla mimica di David Howard Thornton, che malgrado i chili di trucco e il costume debordante ci regala un clown da film muto che sarebbe piaciuto a Tod Browning o Victor Sjöström (penso a He Who Gets Slapped, 1924, da un dramma russo, peraltro ispirazione numero uno di Alex de la Iglesia per Muertos de risa, 1999). Art è la via di mezzo tra l’agghiacciante semplicità del Michael Myers di Carpenter, una forza della natura col coltello in mano e la maschera di William Shatner in faccia, e il brivido metafisico – e metanarrativo – di Freddy Krueger. Con l’aggiunta di un’attrazione fatale per feci, scalpi e budella, e di un senso dell’umorismo perfetto per questi tempi bui. Uno dei momenti più alti di Terrifier 3 è l’incontro di Art con un omone vestito da Santa Claus. Il clown delle carneficine, questo demone in terra che vaga con un sacco della spazzatura in groppa, è un grande ammiratore di Babbo Natale! L’idea spassosa del terzo capitolo è proprio quella di spostare l’azione dalla notte delle streghe a quella del Bambinello, con tanto di riferimenti religiosi a pioggia: stimmate, corone di spine, madonne dell’Ade, presepi e cappelle.
La saga di Terrifier sta per lasciare questa valle di lacrime per buttare il cuore oltre la dimensione terrena. Un rischio enorme degno di Lars von Trier: come rappresentare l’inferno? Come scansare il boomerang dello spiegone escatologico? Intanto, il film uscito in ottobre mette a segno un paio di colpi da maestro. Il più importante per la tenuta generale della serie riguarda il trattamento delle vittime. Leone è sempre stato accusato di sessismo: morti femminili lente e dettagliate, morti maschili sbrigative e poco fantasiose. In Terrifier 3 lo sguardo cambia e l’equilibrio, chiamiamolo di genere, viene ristabilito con gusto. In seconda battuta, la deriva fantasy di T2 viene ridefinita in chiave fumettistica, e anche questo è un bene. Poi c’è il già citato cambio di calendario dagli addobbi di fine ottobre a quelli di Black Christmas e Silent Night, Deadly Night. Infine, letteralmente alla fine del film, la copertina di un libro aggancia il primissimo cortometraggio con Art (The 9th Circle) all’universo diabolico di Polański. Il cerchio si chiude con un pagliaccio triste a cui resta solo la trombetta – che fa più paura di seghe elettriche e altri ammennicoli.
In a Violent Nature di Chris Nash è la rivelazione dell’anno. Anche questo è uno slasher, con una figura solitaria e inarrestabile che fa fuori chiunque le capiti a tiro. Piccola produzione canadese via Shudder, ambientazione lussureggiante in Ontario. Se Terrifier ricorda Freddy e Michael, questo esercizio agghiacciante di disciplina cinematografica tira in mezzo Jason Voorhees. Il titolo dice già tutto, e va interpretato in senso letterale: qui il killer non è una forza ancestrale, ma è la natura che si ribella. Metafora banale, resa eccellente con un metodo complementare a quello di Leone. Nash fa sentire la macchina da presa a ogni passo, le inquadrature sono pianificate con la precisione geometrica di uno Tsai Ming-liang, la commistione di documentario naturalistico e pedinamento dardenniano ci arriva in piena fronte come un’ascia lanciata da tre metri di distanza. I momenti più significativi sono quelli in cui il punto di vista si trova alle spalle della creatura emersa dal fogliame, intenta a marciare per la foresta. Una replica, casuale o inconscia, della scena al piano superiore del convenience store nella Part 15 di Twin Peaks – The Return, quando il Cooper posseduto da Bob viene scortato da un tozzo Woodsman verso gli appartamenti di Phillip Jeffries, e una dissolvenza incrociata fonde un corridoio consunto con una foresta scricchiolante di conifere.
Il film di Nash, di cui è già in cantiere un sequel, funziona come horror esplicito – con un paio di sequenze che svuotano i polmoni – pur spostando tutta l’attenzione dagli attori al piano filmico. Malgrado i meriti artigianali, e l’originalità malata di alcuni ammazzamenti, è la freddezza documentaria a penetrare sottopelle. I corpi sembrano meri strumenti volti a spiegare il funzionamento di un dispositivo meccanico, di un attrezzo da lavoro in dotazione ai ranger forestali. Oltretutto, il mistero non c’è. La prima inquadratura contiene l’innesco della trama, il golem con la vecchia maschera antifumo ha anche un volto che viene tranquillamente ripreso in primo piano, la suspense è annichilita dall’ineluttabilità della natura indifferente che cerca di ripristinare un equilibrio. La forza del film, e il miracolo della sua efficacia, sta nel mettere sullo stesso piano l’attesa e l’attuazione, lasciando nel montaggio delle intercapedini, e delle durate, che qualsiasi film di genere sforbicerebbe per contratto. Ipnotico, solo a tratti minacciato da flashback superflui e recitazione non eccelsa, In a Violent Nature è decrescita felice allo stato puro. Non manca un tocco di Romero ispirato a Land of the Dead, in una lunga sequenza al lago dove sappiamo che il buzzurro ammazzasette sta camminando sul fondale diretto alla prossima vittima, ma non lo vediamo. Nella testa sì.
Des Teufels Bad è un film austriacissimo di Veronika Franz e Severin Fiala che parla di come venivano trattati i casi di depressione grave tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo. Visto che il suicidio è peccato mortale agli occhi del cattolicesimo, la persona che non ce la faceva più a vivere sceglieva di uccidere un innocente per venire poi assolta in confessione – e giustiziata in piena grazia diddio. Più di quattrocento bambini furono uccisi in questo modo. Prodotto da Ulrich Seidl, il “bagno del diavolo” – termine che a suo tempo indicava gli stati depressivi – ha l’andatura perentoria e ossessiva dei suoi film migliori, anche se manca del tutto il tocco sarcastico. Rispetto alla trappola percettiva di Ich seh ich seh (2014) e alla più convenzionale produzione anglofona The Lodge (2019), questa pellicola di Franz e Fiala, con un solido fondamento scientifico, si risveglia negli ultimi quindici minuti dopo un sonno nel bosco non sempre tonificante. La protagonista Agnes (Anja Plaschg) vorrebbe diventare madre, ma si scontra con un marito gay (David Scheid) e una suocera ingombrante (Maria Hofstätter, volto storico del cinema di Seidl). A rendere interessante il film non è tanto la crudeltà del tema, bensì la descrizione in stile pittura su legno delle condizioni di vita in Bassa Austria, tra cascate minacciose, pesca disperata in acque basse, casupole nella foresta, fango e pelli di animale. La natura salta agli occhi più dell’abbozzo di civiltà fagocitato dalla religione e dettato da riti disumani, come la bevuta collettiva del sangue dell’infanticida decapitata, ritenuto un toccasana contro la malinconia. Sullo sfondo di un ambiente ostile e amorale, la cultura è bestiale nei suoi dettami stringenti. Des Teufels Bad è un Heimatfilm al contrario.
Ma il vero orrore arriva col nuovo documentario di Andres Veiel, dedicato a Leni Riefenstahl. Un film di montaggio il cui obiettivo è, ancora una volta, armonizzare l’immaginario e correggere il tiro. Il nome Riefenstahl è universalmente noto, eppure il fatto che abbia inventato il film di propaganda sotto Hitler non è bastato, in questi decenni, a connotarla senza se e senza ma come la nazista che era. Il suo fascino, la furbizia delle sue immagini, il suo talento per la menzogna, la messinscena ex post di un coinvolgimento in qualità di semplice mestierante e i ridicoli tentativi di rilancio dagli anni Sessanta in poi hanno fatto sì che Leni, “donna forte”, la facesse franca sul piano del sentito dire. Adorata da Cocteau e blandita da certo femminismo, negli anni Settanta Riefenstahl riusciva ancora a strappare applausi a scena aperta nei talk show della Repubblica Federale, finendo per ricevere sacchi di fan mail che nemmeno papà Natale in Lapponia. Veiel riprende i punti salienti di questa puntata di Je später der Abend (1976) e soprattutto mostra ciò che Ray Müller non poté, o non volle mostrare montando le tre ore di Die Macht der Bilder (1993), un film agiografico tra le righe spesso passato su Fuori orario in un’estatica cornice. Riefenstahl che si morde le labbra dopo aver ammesso via lapsus un amorazzo con “Dr. Goebbels”, Riefenstahl furiosa dinanzi all’accusa che non poteva non sapere (o non poteva non essere), Riefenstahl in pieno trip coloniale ai tempi del “viaggio fotografico” tra i Nubiani, il volume coffee table che avrebbe dovuto dimostrare, a detta sua, che non era razzista. Niente ideologia, solo bellezza. Niente cultura, solo natura: ecco allora i pescetti tra i coralli delle sue immersioni in tarda età, ripresi da Müller ma non da Veiel, riflesso in Technicolor degli stratagemmi scenografici e di tecnica di ripresa ideati per Triumph des Willens e Olympia; riflesso, soprattutto, del film che Riefenstahl ha portato ad esempio fino alla nausea quale manifesto della sua visione del mondo: Das blaue Licht (1932). Una cortina fumogena in cui si son smarriti in tantissimi, perdendo di vista lo spirito völkisch fino al midollo di questo suo film di debutto, le statue vive in stile greco-ariano che aprono Olympia, le comparse rom e sinti per Tiefland (1940; terminato nel 1954) prelevate da un campo di concentramento e ivi rischiaffate, finendo cadaveri. Riefenstahl andò a processo per questo suo ultimo lungometraggio asserendo di averle incontrate tutte, sane e di robusta costituzione, dopo la fine della guerra. Una bugia a cui molti piacque credere, dimenticando tra l’altro che l’opera Tiefland era una delle preferite da Hitler.
Veiel ha ricevuto dalla produttrice, la giornalista Sandra Maischberger, la proposta di fare il film dopo la morte dell’ultimo marito di Riefenstahl, che ha reso accessibile l’enorme archivio dell’attrice e regista. Un archivio organizzato e curatissimo, un guanto infilato sulla sua strategica comunicativa. Riefenstahl ha avuto sessant’anni di tempo per salvarsi dalla damnatio memoriae, cioè da quando nel 1939 la sua ascesa irresistibile si tramutò in una battuta d’arresto. Dopo i fasti del doppio film sulle Olimpiadi berlinesi, che di fatto gettò le basi delle moderne riprese sportive, Riefenstahl venne mandata al fronte in Polonia. Avrebbe dovuto scolpire l’avanzata tedesca nel marmo della propaganda, ma nel giro di poche settimane rinunciò all’incarico. Veiel non ha trovato pistole fumanti di suo pugno nell’archivio, ma tramite la corrispondenza indiretta è riuscito a ricostruire un incidente avvenuto a Końskie, quando più di venti operai ebrei furono fucilati. A quanto pare, Riefenstahl stava girando in strada, un gruppo di persone era al lavoro sullo sfondo, così ordinò “Weg mit den Juden” per ripulire l’inquadratura, un comando che i militari al suo seguito interpretarono in chiave nazista, freddando tutti a un tiro di schioppo dalla cinepresa. Ecco allora, come sottolinea la voce narrante del film, che un’indicazione di regia firmata Riefenstahl provoca un massacro. Nessuna responsabilità?
A più di vent’anni dalla morte della diretta interessata e a trenta dal documentario-intervista di Müller, Riefenstahl di Andres Veiel mette finalmente i puntini sulle i di una carriera senza scrupoli troppo spesso offuscata dal carisma e dalla forza delle immagini. Il film montato da Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer e Alfredo Castro offre un ritratto a trecentosessanta gradi del suo soggetto, dalle foto favolose degli anni Venti ai film di montagna di Fanck e Trenker, dai tappeti rossi internazionali per Olympia alla sua complicità con Albert Speer, compagno di telefonate e ciaspolate per scambiarsi consigli editoriali e spremere a dovere la rapa della nostalgia nazi di tanti tedeschi. Una lunga performance con faccia di bronzo fino all’ultima apparizione nel 1999, ultranovantenne preoccupata dall’illuminazione che rischia di tradire le rughe. In tv, va da sé, passò solo l’ennesima intervista supina. Veiel ci fa capire come mai attorno a Riefenstahl è nato un mito, ma anche la pericolosità e l’attualità di questo mito fondato sul cinismo intellettuale. Parlare di Riefenstahl oggi significa anche parlare di propaganda – nazionalsocialista, quindi populista ante litteram. L’uomo solo al comando che blatera di pace e lavoro per tutti, che promette mari e monti alla maggioranza acritica regalandole facili emozioni ai danni delle minoranze. Al contrario di Dietrich, Riefenstahl restò in Germania malgrado fosse una star internazionale perché sapeva di potercela fare lì, nell’Heimat, usando la bellezza apollinea come schermo protettivo per l’ultraviolenza. La vera arte degenerata.



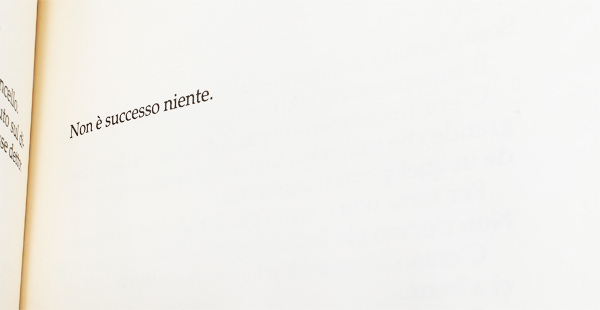
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.