Se c’è una cosa che faccio tutti i giorni, cascasse il mondo, è guardare i due video pubblicati da David Lynch. Dall’11 maggio 2020, 318 giorni fa, ogni mattina – da noi le 16 – fa il punto sul meteo guardando fuori dalla sua finestra a Los Angeles (e leggendo le temperature su un qualunque sito di previsioni meteo). Dal 17 agosto 2020, 220 giorni fa, ogni mattina, circa un’ora dopo aver parlato di celsius e fahrhenheit, blue skies and golden sunshine, pesca una pallina da ping pong da un grosso barattolo di vetro dipinto di nero dalla base a metà altezza. Le palline sono dieci, numerate. Quella che esce previo giramento vorticoso (“Swirl the numbers”) indica il numero del giorno. Fine.
Il Weather Report è una vecchia idea risalente ai primi anni zero, quando Lynch aveva un sito .com, a pagamento, usato come vetrina di progetti sperimentali. A suo tempo, quasi vent’anni fa, usava una cam di quelle che avevamo anche noi, qualità infima e immagine sgranata, mettendocisi davanti sempre nella stessa posizione per alzare gli occhi al cielo e constatare lo stato delle cose. Ogni tanto, una variazione. Lui che legge Maxim indossando guanti da lavoro. Un pupazzo stile Mr Oizo al posto suo, sulla seggiola. Laura Dern in visita. Tra gli altri contenuti del sito, da tempo defunto, la miniserie Rabbits (inserita tra le schegge impazzite di Inland Empire) e un gioiellino in flash, il grottesco cartone animato Dumbland, quanto di più anale abbia mai fatto. Su Youtube non si trova più.
Prima di aprire il canale con l’aiuto della fedele produttrice esecutiva Sabrina Sutherland, Lynch stava su twitter. Ci sta ancora, con parsimonia. Via twitter annunciò nell’ottobre del 2014 la terza stagione di Twin Peaks, coordinandosi con Mark Frost in una storica sequenza di cinguettii. E già su twitter si coglie uno degli aspetti salienti del Weather Report, ovvero la ripetizione rituale. Ogni testo si apre con Dear Twitter Friends, cosa che ai tempi dei 140 caratteri se ne mangiava una bella fetta, caricando a dismisura le poche parole successive.
Cosa c’è sul canale a parte il meteo e il numero del giorno. Ci sono dei corti, per l’esattezza un’antologia di corti rari (Pożar, The 3Rs, Scissors, il video musicale I Have a Radio), una versione ampliata di Rabbits e alcune novità girate e montate in quarantena con mezzi semiamatoriali. Corti improvvisati in giardino (The Story of a Small Bug, Ball of Bees #1, The Spider and the Bee) e altri che ricordano gli inizi lynchiani pre-Eraserhead (The Adventures of Alan R., The Mystery of the Seeing Hand). C’è la serie, irresistibile, dei video What Is David Working On Today?, in cui il padrone di casa, noto appassionato di bric-à-brac, ci mostra un lavandino in legno, un orinale, un reggimicrofono e un reggicellulare (sempre in legno), delle litografie da firmare, delle braghe da rammendare, uno specchio, la boccia e le palline di cui sopra prima dell’avvio dell’estrazione giornaliera. Un video intitolato Thinking ci accompagna nel sottoscala, dove il vaso attende di entrare in azione. Per fortuna, questo corto d’atmosfera montato con qualche effetto visivo è l’unica cosa che si avvicina, senza citarla, alla follia settaria della meditazione trascendentale. Un’altra breve serie di video “lavorativi” (sempre introdotti da un cartello oscillante con tanto di trapano sullo sfondo) descrive la nascita del cosiddetto “incredible checking stick”, un bastone fatto in casa con elementi di spago e metallo che se puntato su un quadro ti aiuta a capire come procedere con la creazione. OK.
C’è anche un video di trenta minuti, isolato, in cui Lynch si lancia in un Q&A partendo dai commenti sul canale. E c’è quella che sembra una ripresa, buttata lì, di Dumbland in loop: How Was Your Day Honey? Durante il rapporto meteorologico ci può scappare la descrizione di un sogno, un consiglio musicale (soprattutto anni Cinquanta, ma anche i Beatles con A Day in the Life e Here Comes the Sun), qualche dichiarazione d’amore al legno e ai ruscelli, ingenui riferimenti alla politica americana. Regolarmente ci scappano auguri di compleanno agli amici – tipo Paul McCartney – e ogni tanto compare un cartoncino scribacchiato, sia esso per sostenere il movimento Black Lives Matter o per festeggiare San Valentino. Il 18 ottobre è rimasto zitto per un minuto di fila. Il 9 novembre ha scazzato di brutto il rito del numero, inquadratura compresa, con effetti esilaranti. Può capitare un video virato al blu o uno col suono distorto.
Stando a quanto afferma nei clippini, Lynch non è uscito di casa una sola volta dallo scorso maggio, con l’eccezione del doppio giro per vaccinarsi. I due video quotidiani sono statici, quasi sempre la medesima inquadratura (con un doppio cambio dal 7 novembre per questioni di luce naturale). Durante l’estate sono apparsi degli occhiali da sole terapeutici che ormai non si toglie più e che garantiscono una mise en abîme di riflessi con gli schermi. Il respiro è spesso udibile, corto. La barba, dal 2021, in crescita incontrollata. L’estrazione del decalotto avviene di solito con un cappello fluorescente da cowboy, giallissimo, calato sulla folta capigliatura bianca.
Il 31 gennaio, un’altra birbonata in stile bastone da creazione. Annuncia un annuncio per il giorno successivo, web in delirio, poi si scopre che l’annuncio doveva in teoria segnare la fine dei clippini ma David ha cambiato idea grazie ai tanti commenti, va avanti imperterrito finché ce n’è. L’entrata in produzione della nuova serie per Netflix, Wisteria / Unrecorded Night, è prevista per maggio. Lo si sa dallo scorso autunno per via ufficiosa, dettagli racimolati su testate per addetti ai lavori e in uffici polverosi deputati al deposito di titoli protetti da copyright. Il diretto interessato, da sempre maestro nel seminare indizi ingannevoli, non smentisce né conferma. Il mistero, per essere mistero, dev’essere misterioso e imperscrutabile. Se spieghi è la fine.
Eppure, il David Lynch Theater, tutto maiuscolo, non è fonte di mistero. Con la sua ossessiva, tranquillizzante ritualità, la sua ripetizione minimalista, random e innocua come l’estrazione di un numero tra 1 e 10, l’esposizione quotidiana di un uomo di 75 anni, fumatore incallito, è un esperimento di trasparenza. Un gesto di vicinanza da parte di chi, raccontando una storia, ama incrinare il lieto fine. Scuotere il puzzle. Negare qualsiasi conclusione logica, qualsiasi closure da blockbuster. In questo teatrino, che potrebbe benissimo essere quello della signora del radiatore, si respirano l’onestà e la lentezza di The Straight Story. Come andrà a finire, forse tra le stelle, non si sa. E che importa poi?
Conta la certezza. Di poter fare affidamento su questo canale in tempi di attesa slabbrata e confinamento. Conta sapere che domani mattina a Los Angeles, e domani pomeriggio in Europa centrale, un uomo in primissimo piano si sorprenderà per l’ennesima volta del quinto giorno della settimana: “If you can believe it, it’s a Friday once again”.


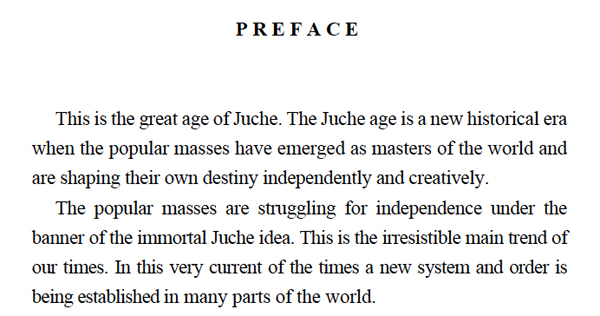


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.