
Francis Ford Coppola ha due rimpianti. Il primo è non aver trovato la forza di licenziare Vittorio Storaro all’inizio delle riprese di One from the Heart, quando il direttore della fotografia si oppose all’idea di girare il film come una serie di piani sequenza. L’idea di Coppola, da lui battezzata “live cinema”, era di riprendere il tour de force hitchcockiano di Rope (1948) spostandolo in un teatro di posa molto più grande, ovvero i nuovissimi e ultratecnologici Zoetrope Studios. Sebbene si parlasse già di digitale, che al tempo significava video, quindi fondamentalmente videoclip e potenziamento del mezzo televisivo (una sperimentazione cara anche ad Antonioni nei primi anni Ottanta), le macchine da presa andavano ancora a pellicola, e come per Hitchcock la durata massima di un piano sequenza era di dieci minuti. One from the Heart ha conservato il concept di film teatrale – e musicale – al neon, tra le pareti di un mondo a parte come i teatri di posa di cui andavano gelosissimi Jean-Pierre Melville o Jacques Tati, ma sul fronte del montaggio non spacca, per sottrazione e virtuosismo, come avrebbe voluto Coppola. Il secondo rimpianto è aver lasciato alle giovani generazioni una Hollywood non migliore di quella che aveva trovato. Rimpianto probabilmente condiviso dai sodali della New Hollywood degli anni Settanta, sonoramente schiaffeggiati a cavallo del decennio Ottanta da una serie di flop – economici – clamorosi. Scorsese con New York New York, Spielberg con 1941, Cimino con Heaven’s Gate, e Coppola proprio con One from the Heart. Il terzo grande rimpianto sarebbe stato quello di non fare Megalopolis. E invece.
Megalopolis c’è, ed è una festa. Il progetto è esistito nella testa di Coppola per almeno quarant’anni, e rappresenta di fatto la prima corazzata post-Apocalypse, oltre che la prima sceneggiatura coppoliana del tutto originale dopo The Conversation (1974). Da spettatori, sappiamo che negli anni Ottanta Coppola non si è fermato un attimo, portando sullo schermo uno sciame di “semi misteriosi”. Così chiama Alice Rohrwacher i lavori su commissione, sceneggiature o proposte che arrivano via etere, talvolta via posta. Nel caso di Rohrwacher, Le pupille (2022) è l’esempio principe di un seme misterioso da cui sboccia una piantina perfetta. In sostanza, tutti i film diretti da Coppola negli anni Ottanta e Novanta sono semi misteriosi, adattamenti e prodotti di genere, sebbene la sua impronta non manchi mai. C’è chi sostiene, ad esempio, che Tucker (1988) sia il film più eloquente sulla poetica coppoliana, grazie alla metafora del genio idiosincratico, isolato e fallimentare in stile Tesla. Rumble Fish (1984), col suo bianco e nero, i pesci colorati e la rabbia giovane che lo innerva, è al contempo un reboot d’autore di The Outsiders (1983) e la prima, decisa virata di Coppola verso un cinema libero dai lacci dell’industria. Persino Peggy Sue Got Married (1986), solo in apparenza un sottoprodotto di Back to the Future (1985) visto che la sceneggiatura è antecedente, è intriso della classica malinconia coppoliana e a posteriori rappresenta il primo capitolo della sua riflessione sul tempo, proseguita con Bram Stoker’s Dracula (1992), Jack (1996), Youth without Youth (2007) e Megalopolis. O meglio: cominciata con Megalopolis.
Sempre citando Rohrwacher, Megalopolis è una pianta autoctona. Nata e cresciuta nell’orto del suo giardiniere. Le meraviglie (2014) è una pianta autoctona. Lazzaro felice (2019) è una maestosa, commovente pianta autoctona. Nella filmografia di Coppola, The Conversation lo è, Apocalypse Now lo è, e dagli Novanta il controllo autoriale, o agreste, si riaffaccia: un Dracula girato con idee artigianali da fine Ottocento, tutto effetti ottici e costumi, una commedia sghemba che in realtà rielabora la morte di un figlio (Jack), la decisione a partire da The Rainmaker (1997) di tornare a scrivere personalmente le sceneggiature. Uno scarto che si sente, tanto da trasformare un semplice “Grishamovie” in una pellicola straziante e riuscita. Anche i tre piccoli film realizzati tra il 2007 e il 2011 sono quanto di più autoctono potesse permettersi Coppola all’epoca, col gravame di una fama ancorata agli anni Settanta. Tetro (2009), di nuovo in bianco e nero, è la quintessenza della sua filosofia: un poemetto abbacinante sulla famiglia e la ribellione (soprattutto visiva). Persino Twixt (2011) è una pianticella autoctona, con la sua esile riflessione sull’autorialità e il parziale ricorso al 3D, allora di moda, che vale come un ritorno alle origini, alle produzioni sghembe di Corman e Castle, quindi al debutto di Coppola con Dementia 13 (1963). Già Twixt è una favola ancestrale. Il sottotitolo di Megalopolis è “A Fable”.
Megalopolis è una festa. Come alcune feste, ci mette un po’ a ingranare e non tutti i momenti sono memorabili. Il gradino più alto riguarda l’iniziale sospensione dell’incredulità. Siamo in una New York del futuro ribattezzata New Rome, immersa in colori gialli metallizzati. Se ci si aspetta da Megalopolis un tuffo nell’immaginario immediato e ipnotico come in Blade Runner, meglio abbassare l’asticella. Spesso, puntando alla grande forma, il film non ce la fa, ed è doloroso dire che il grosso della sua produzione, cioè le riprese dal vivo e l’afflato magniloquente, partoriscono topolini. Va detto però che Megalopolis dovrebbe chiamarsi Multilopolis, perché schizza in tutte le direzioni e fa capire, gradualmente, qual è il suo punto di forza. Che non è certo nella concretezza delle immagini o nella solidità della sceneggiatura. Aggiornato, come ha ribadito più volte Coppola, centinaia di volte, lo script sembra essersi allentato invece di blindarsi, e probabilmente l’andamento a singhiozzo delle riprese ha agevolato un’ulteriore mutazione. È un film di fantascienza, Megalopolis? Non tantissimo, sicuramente meno di Metropolis. È un film politico, un pamphlet sociale sull’America? Non più dei Padrini o di Tucker. È un viaggio, come Apocalypse Now? No. È un film stanziale, un film-città, una distopia che si tramuta in utopia, recando quindi una struttura da commedia. Megalopolis è soprattutto un film visionario senza filtri, anche di buon senso, una festa privata. Per una decina di minuti diventa persino un incredibile body horror. È un magma di cinema che contiene tutto e il suo contrario, una canzone cantata da Grace VanderWaal in una mezzaluna appesa e un videoclip metal sparato di pacca tra le fiamme.
Megalopolis funziona quando crolla, quando si sfalda. Le scritte scolpite nel marmo, sparpagliate in tutto il film e memori di Bram Stoker’s Dracula, sono credibili come la cartapesta che anticipa daghe e sandaloni. Anche i tentativi di ammodernare una vecchia sceneggiatura sembrano non essersi spinti oltre l’idea di mostrare dei QR code. Sul fronte attoriale, Adam Driver pare reduce da una sessione di SNL, e malgrado la compresenza di Jon Voight e Dustin Hoffman il film buca una possibile reunion di Midnight Cowboy, che avrebbe potuto replicare la scaltrezza del dialogo al diner in Heat (1995) tra De Niro e Pacino. Hoffman a un certo punto scompare insieme alla sua sottotrama, schiacciato in meno di cinque secondi da delle colonne che crollano e sostituito da una statua a futura memoria. Una exit strategy che ricorda l’esilio di Joan Chen nel pomello di un cassetto, seconda stagione di Twin Peaks. In Megalopolis il racconto zoppica, la creazione di un universo è ondivaga, tenue, ma il nucleo del film non ha bisogno di questi vecchi mezzi da Ben Hur. Per creare l’atmosfera di una megalopoli futuribile ha solo bisogno di un’immagine, cioè la cima dell’Empire State Building.
La svolta è il momento dell’interazione col pubblico. Una scena entrata nella storia a Cannes, quando il film venne presentato in concorso. Alcuni secondi di buio, una piantana con microfono sistemata davanti allo schermo, e Jason Schwartzman che interpella Cesar Catilina (Driver) nel film. Una trovata non replicabile su larga scala, tant’è che nella versione standard per le sale la voce dell’intervistatore è off, mentre Driver risponde all’interno di un rettangolino in basso, circondato dal buio dello schermo. Se fino a quel momento Megalopolis ha regalato solo episodici sprazzi, l’idea grandiosa delle statue vive che crollano, una scrivania immersa nella sabbia, singole inquadrature lampo inserite come le animazioni spiazzanti di Jane Campion, il rush finale è tutto visivo. In un certo senso, è come The Godfather Part III che dà il meglio di sé nell’ultima macrosequenza della Cavalleria rusticana. Ma in Megalopolis non sono le riprese a salvare il film, bensì il montaggio – di Cam McLauchlin e Glen Scantlebury – che regala sempre più spesso una sinfonia di dissolvenze incrociate in pieno stile Coppola. La narrazione per immagini spiega le ali tramite una fusione di immagini. Non solo: intervengono altre transizioni classiche, come lo split screen (a tre schermi, come Abel Gance) o il “tondino” che restringe l’inquadratura su un dettaglio, spesso un volto. Il film termina con un tondino – e con questa canzone-manifesto – così come One from the Heart apre il sipario su un tondo che va a coincidere con la luna. In Megalopolis, il sindaco Cicero (Giancarlo Esposito) sogna una mano che spunta dalla nuvolaglia per afferrare la luna, una parentesi degna di Meliès.
Megalopolis sbanda tra momenti di puro Nascar cinematografico e una “lively conversation”, anche su di noi, l’America e il pianeta, tanto ambiziosa quanto credibile. Il misterioso materiale organico Megalon che l’architetto Cesar utilizza per le sue costruzioni arriva a invadere il suo stesso corpo e la struttura del film, che pulsa come un’alga misteriosa, un metallo raro, un elemento nuovo sulla tavola di Mendeleev. Quello che racconta, in termini di parole pronunciate e azioni mostrate, conta il giusto. Megalopolis è un’ode alla famiglia intesa come trasmissione del sapere e della speranza, una Tucker roboante lanciata su autostrade perdute, un salto di libertà nel vuoto più assoluto. Molto semplicemente, un atto creativo allo stato brado.
Da un quarto di secolo, Coppola sforna director’s cut e rimaneggiamenti dei suoi film. A cominciare da Apocalypse Now, ora disponibile in tre montaggi uno più bello dell’altro. The Outsiders, The Cotton Club, The Godfather Part III esistono in versione rimontata, non sempre facilissima da reperire. Persino Twixt ha fatto il tagliando, e nel 2023 è uscita una versione Reprise di One from the Heart, più breve rispetto all’originale. In gran parte si tratta di vecchi semi misteriosi, figli del compromesso, che ora recano un’impronta più profonda del loro autore. Improbabile che Megalopolis, pianta autoctona cresciuta nell’ombra per quasi mezzo secolo, sia sottoposta a un trattamento del genere. Continuerà a crescere, questo sì, e a cambiare, negli occhi di chi l’ha vista. Un po’ come un altro film unico e irripetibile, l’unico che Coppola cita esplicitamente in Megalopolis: The Night of the Hunter (1955).
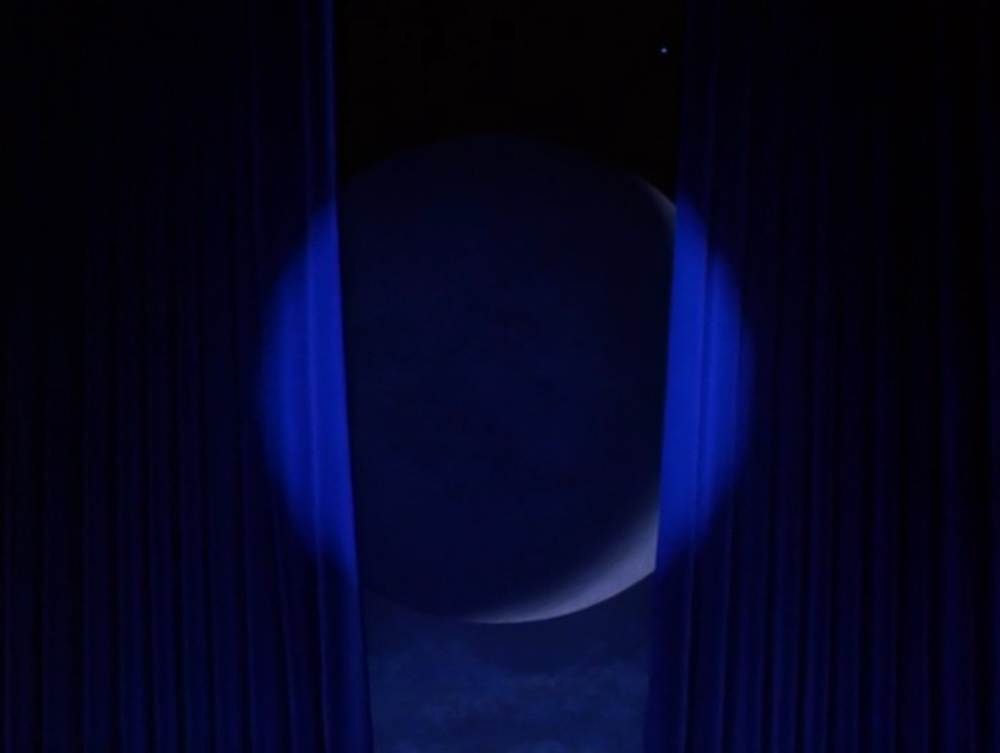

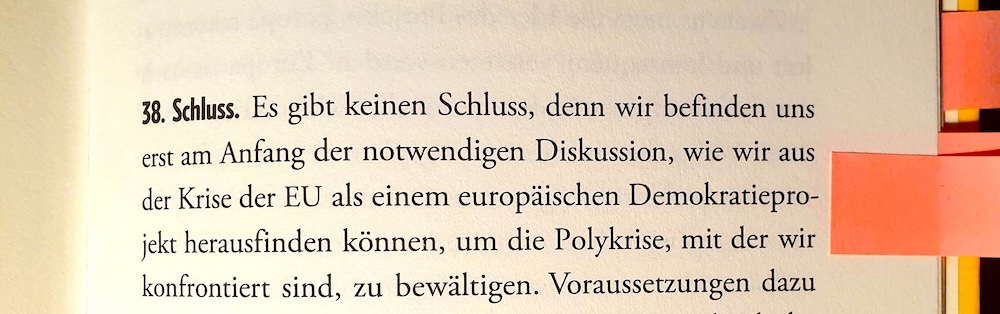

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.