
In questo agghiacciante mese di gennaio è morto Karl Riha, massimo esperto della branca berlinese di Dada, direttore del Literarisches Colloquium ai tempi della Wende, persona squisita che mi aiutò a portare in Italia l’Oberdada. Correva l’anno duemilaundici e Simone Bedetti, tuttora editore di Area51 Publishing, mi propose di tradurre le Quattordici lettere del Cristo, opera sghemba tra le tante, claudicanti trovate dell’architetto Baader, dadaista non di punta ma almeno berlinese d’adozione – quindi sghembo dentro. Per prepararmi alla traduzione di quello che sarebbe uscito come ebook, un ebook che per la cronaca non ha letto nessuno, mi feci una cultura e soprattutto dovetti trovare un modo per risalire al testo originale, datato 1914 e quindi ufficialmente pre-dadaista. In rete non c’era, e direi che ancora non c’è. Sul mercato non c’era più, e continua a non esserci. Non avevo la tessera della Stabi, dove hanno una copia dell’edizione accademica del 1988 a cura di Karl Riha. Né sapevo ancora come funzionano i cataloghi on line delle biblioteche prussiane. Ergo, giunsi alla conclusione che l’unico modo per recuperare le epistole deliranti dell’Oberdada fosse scrivere al professor Karl Riha. Che mi rispose pure, arrivò a telefonarmi e a mandarmi per posta la sua copia dell’edizione Peter Lang. Ricevetti incredulo quel volumetto dalla copertina gialla e a lavoro fatto glielo rispedii con lettera commossa. L’ebook si fece, ci misi del mio aggiungendo qualche altra trouvaille baaderiana, come un’assurda lettera a Hitler (Baader amava scrivere ai pezzi grossi, meglio se di merda, dettando condizioni e millantando titoli interplanetari), l’ebook uscì, e come dicevo, non l’ha letto nessuno. Peccato, mi vien da dire dopo quindici anni, perché l’Oberdada era davvero una sagoma. Ora che Karl Riha ci ha lasciati, appoggio qui la sua postfazione del 1988, delicatamente abridged e rinfrescata sul piano traduttivo.
Oberdada, un ritratto cubista – di Karl Riha
Chi era, davvero, Johannes Baader? Cos’ha combinato in vita? E soprattutto: credeva in quello che faceva o era solo un teatrante? Difficile, ancora oggi, rispondere in maniera univoca a questa batteria di quesiti. In assenza di biografie ufficiali o di testi autografi di argomento biografico, possiamo solo affidarci a un “sentito dire” molto speciale. Ciascuno degli esponenti berlinesi del dadaismo si è infatti pronunciato sull’Oberdada e gli ha dedicato, a modo suo, un ritratto. Abbiamo quindi a disposizione un corpus di testimonianze di prima mano, per quanto a volte contraddittorie o animate da umori di natura personale. Trattasi di ricordi e aneddoti prodighi di dettagli sulla vita e l’opera di Johannes Baader, che vanno a formare l’unica fonte degna di questo nome in grado di restituirci la sua figura. All’ultima, ipotetica domanda “Ci si può fidare di Dada?” è meglio non rispondere.
L’anarchico Franz Jung, che già agli inizi del movimento ricopriva un ruolo importante, annota nella sua autobiografia Der Weg nach unten (1961) che Raoul Hausmann si era imbattuto in Baader – sua vecchia conoscenza – alla fine della Prima guerra mondiale, in un “grezzo paesaggio collinare” nei pressi di Steglitz (profondo ovest berlinese) dove il Nostro, circondato da un crocchio di persone anziane, andava predicando “l’esercito dell’uno e del solo che quando il tempo verrà, sconfiggerà tutti gli altri eserciti: io, Johannes Baader, diventerò suo maresciallo operativo”. Nelle parole di Jung, “Hausmann lo portò nel suo atelier e gli cucì addosso la figura dell’Ober-Dada. Ignoro quali strumenti e quali tecniche Hausmann abbia impiegato”. Dopodiché, “Hausmann ha fatto di Baader, uomo innocuo e gentile, una creatura demenziale, utilizzabile alla stregua del tabaccaio all’angolo. Lo ha trasformato in un manichino di sé stesso, una sorta di punching-ball. Baader si muoveva e parlava solo e soltanto in base alle istruzioni di Hausmann”.
Di opinione molto diversa è Walter Mehring, cofirmatario del manifesto dadaista del 1918 e a sua volta figura cruciale di Dada Berlin. Nel suo libro di memorie Berlin-Dada (1959) egli fa riferimento a svariate testimonianze dirette, come quella di Jung, e asserisce che alcuni colleghi del movimento avevano archiviato Baader come un “autentico idiota” più che come un “innocuo manichino”, condannandolo al dimenticatoio. Mehring aggiunge che “da dadaista convinto della prima ora, nutro un sentimento di profondo rispetto nei confronti del nostro immortale Oberdada, un sentimento negatogli da quasi tutti gli altri”. A suo modo di vedere, “Baader era senza dubbio il più onorevole e sublime della nostra cerchia”, poiché “da lui emanava un fluido radioattivo, quello dei dervisci, dei marabutti africani, degli starec russi, dei rabbini magici polacchi o dei moderni profeti Geremia che, con indosso un saio logoro e sandali sbrindellati, vagano per le paludi della corruzione, per i marciapiedi di Broadway e per il Columbus Circle stringendo in pugno un monito scribacchiato su un pezzo di cartone: ‘Domani è il giudizio universale / Guardatevi dentro oggi!’”
Nel testo DADA-Kunst und Antikunst (1964), Hans Richter lascia un’opinione ancora più positiva. “Col suo spirito di ribellione che non si fermava davanti a nulla”, scrive. Secondo lui, Johannes Baader è stata “la massima espressione del dadaismo berlinese ai tempi della rivoluzione del 1918-1919. Non disponeva solo di un metodo rivoluzionario, ma anche di una straordinaria capacità persuasiva. Era come se quell’improvviso crollo dell’ordine costituito avesse elevato alla massima potenza la sua immaginazione, la sua fantasia. Il caos che circondava lui e noi tutti sembrava l’ultima, definitiva conferma della disgregazione della vecchia Europa. Questa consapevolezza lo manteneva in uno stato di costante euforia, gli toglieva ogni freno inibitorio. […] Non era un artista, o meglio, non lo era nel senso classico del termine, ma la sua personalità si esprimeva in una chiave che può essere solo definita artistica. Era un posseduto, e la sua estrema spontaneità, in quei tempi di cambiamento, in quella società di ribelli, non era solo ben accetta, ma anche ammirata. Era un candelotto di dinamite che saltava in aria da solo”.
La testimonianza più chiara, intensa e – nonostante tutte le relativizzazioni del caso – autentica, ci viene da Raoul Hausmann. Che sia stato lui a modellare la figura dell’Oberdada, come dice Jung, trova conferma nelle sue parole, ma l’artista ci tiene a precisare che Baader, “in virtù della sua naturale irrealtà”, era l’esponente perfetto del movimento Dada. Baader è, nelle parole di Hausmann, “un monomaniaco acuto ed estraneo alla logica, capace di sbattere la testa contro il muro per un’idea”.
In un articolo piuttosto lungo apparso nel 1967 sulla rivista letteraria austriaca «Manuskripte», Hausmann ripercorre la vita pre-Dada di Baader e parla del “dadaismo naturale” insito in lui: “Concepiva la vita da un punto di vista del tutto alieno a quello della gente normale, ragionevole e borghese, perciò era costretto ad aggredire quello stile di vita sedentario. La filosofia, la logica, pure l’estetica non avevano alcun valore per lui, poiché fondamentalmente era uno dei pochi uomini davvero liberi, destinati a non trovare posto nella società”.
Tra le azioni compiute “per Dada, prima di Dada […] già Dada”, Hausmann menziona un viaggio a Weimar. Baader sosteneva infatti di avere un paio di questioni da dirimere con Goethe e Schiller. Dopo un incontro incorporeo con la dea (o dio, non è dato sapere) Amida nel corso del viaggio, Baader fu sopraffatto dalla netta frattura tra le “cose pragmatiche” e i “segnali mistici” e finì, dopo una crisi alla stazione di Weimar che gli fece perdere i sensi, in una clinica psichiatrica. Là non gli venne riscontrato alcuno stato di infermità mentale, anche se la cosa pare in contraddizione con i bloc notes che portava sempre con sé e in cui annotava “ogni minimo avvenimento di cui era stato testimone oculare, con tanto di orario preciso al minuto”. Qualche esempio. “Ore dieci di mattina. Dieci e tre minuti, compro un sigaro per 3 pfennig. Dieci e sette minuti, compro una marca da bollo da 3 pfennig – e così via”. La folle scientificità del metodo Baader, già evidente in queste prime azioni dadaiste, gli venne in aiuto durante la guerra. Quando nel 1916 gli inviarono la cartolina di precetto, lui si mise alla scrivania e vergò una lettera indirizzata al principe Federico Guglielmo. Eccola: “Mio caro principe! Oggi sono divenuto soldato nell’esercito di tuo nonno, il dominatore del regno della violenza. Dato che io sono il signore del regno dello spirito, non posso sottostare ai comandi di un dio minore. Perciò ti chiedo, anzi ti incarico di comunicare a tuo nonno che gli ordino di cessare immediatamente ogni azione guerresca e di avviare le trattative di pace sotto la mia guida. Con i migliori saluti per te e per il nonno, Johannes Baader”. Un ulteriore aneddoto narra il secondo capitolo di questa faccenduola che vede Baader arruolato a Bruxelles, tra i ranghi della sua Landsturm-Kompagnie. Invece di rassegnarsi alla trincea, pare abbia preteso di parlare con l’imperatore Guglielmo in persona per dargli ordine – un ordine divino, va da sé – di dichiarare la pace con effetto immediato. Poco conta come sia andata in realtà: alla fine, Baader venne ritenuto inadatto alle ostilità, e riformato.
Il suo tentativo del 1917 di candidarsi a Saarbrücken per le elezioni del Reichstag in qualità di “architetto Baader”, rientra già a pieno titolo nel contesto di Dada Berlin. Alcuni estratti del suo accorato appello agli elettori li ritroviamo stampati a caratteri rubizzi sul prospetto del “Club Dada” (noto anche come Club zur blauen Milchstraße) che uscì sulla «Freie Straße» diretta da Jung. Già nell’estate del 1917 Jung e Hausmann decisero di interrompere il piano di “silenzioso congelamento della grande massa” e passare all’azione punzecchiando lo “status quo generale sottomesso” mediante azioni mirate. Per un’operazione del genere, “un posseduto come Baader” parve loro la pedina ideale. “Andai con lui per i campi a sud di Berlino, dove viveva Jung” scrive Hausmann “e gli dissi: un giorno tutto questo sarà tuo, se farai quel che dico. […] Io voglio porti al di sopra degli altri esseri umani. Ciascuno ha il diritto di essere divino. Da oggi, tu sei presidente della Christus Gmbh e devi trovare altri membri. Devi convincere ognuno che anche lui, se lo vuole, è Cristo, a fronte di un pagamento di 50 marchi. In quanto membro della nostra società, non sarà più suddito dell’impero, ergo automaticamente riformato”.
Secondo lo scrittore ed editore Wieland Herzfelde, molto vicino ai dadaisti, il battesimo di Baader quale Oberdada risale al fatidico novembre 1918, quindi tra la fine della Grande guerra e i primi vagiti della Repubblica di Weimar. In coincidenza con l’uscita del terzo numero della rivista «Der Dada», Herzfelde conserva il seguente ricordo riguardante il famigerato Club Dada, che sfata almeno in parte la vulgata corrente: “Ciascuno poteva chiamarsi dadaista, solo che doveva trovare da solo un motivo affinché gli altri lo ritenessero tale. Per dirne una, ci siamo imbattuti in un tizio che sventolava un ‘permesso di caccia’ che lo esonerava, a detta sua, dalla responsabilità giuridica di ogni azione. Lo abbiamo conosciuto […] presso il nostro stampatore, dove era andato a ritirare una nuova edizione delle Quattordici lettere del Cristo, da lui scritte. Si è presentato come ‘Il Presidente dell’Orbe Terracqueo’, al che l’abbiamo portato con noi all’atelier di Grosz, gli abbiamo conferito il titolo di Oberdada e lo abbiamo trattato con tutti gli onori. Queste vicende ci hanno in seguito attirato alcune critiche, ma va detto che lui, l’architetto Johannes Baader, si prendeva dannatamente sul serio, e prendeva sul serio anche il dadaismo”.
Poco dopo la costituzione della Repubblica di Weimar “Baader, che si era fatto crescere una lunga barba pastorale, tenne un discorso con voce minacciosa che si sentì fino in strada, nel corso del quale nominò Philipp Scheidenmann dadaista d’onore. Scheidenmann era un deputato dell’SPD che Baader aveva incontrato per caso sul tram. L’onorevole reagì imbarazzato, e vista la folla che si era raccolta attorno a loro gli ci volle un po’ per dileguarsi. Poche settimane dopo, nel febbraio del 1919, Scheidenmann venne nominato cancelliere: l’Anschluss Dada-rivoluzione weimariana era compiuta!” A riportare questo episodio è di nuovo Franz Jung.
Le due azioni più memorabili di Baader furono l’interruzione della predica del cappellano Ernst von Dryander nel duomo di Berlino, datata 17 novembre 1918, e il proclama pubblicato su «Die grüne Leiche» (“Il cadavere verde”), che venne gettato sulla folla dell’assemblea nazionale di Weimar nel luglio dell’anno successivo. Questi gesti costituiscono lo zenith del Baader “azionista dadaista” del ramo berlinese. Grazie al loro impatto spettacolare e alle reazioni scomposte che provocarono, le due boutade garantirono una pubblicità al movimento dadaista che la sola realizzazione di manifesti e riviste non avrebbe mai potuto eguagliare.
Per l’azione nel duomo esistono, al solito, cronache discordanti. Hausmann sostiene che Baader, mentre Dryander era in procinto di cominciare la predica, abbia urlato a chiare lettere: “Un attimo! Io le chiedo cosa è per lei Gesù Cristo. Gliene frega qualcosa…?” Non riuscì a dire nient’altro, perché scoppiò un’inenarrabile baraonda. Baader venne arrestato con un’accusa di blasfemia che si tramutò in un nulla di fatto, dato che aveva con sé il manoscritto del discorso integrale che intendeva pronunciare, una filippica contenente frasi generose nei confronti di Cristo (e ingenerose in quelli di Dryander) quali ‘lei ignora i Suoi comandamenti’ e affini. Secondo Walter Mehring, invece, Baader rispose alla domanda di rito “Cos’è per voi Gesù Cristo?” formulata da Dryander con la seguente provocazione: “Per lei è un panino alla pinzillacchera, signor pastore!”. Hans Richter, dal canto suo, scrive che Baader, dall’alto della galleria, rispose alla domanda del canonico gridando “Per me, Cristo è una pinzillacchera”, e a quell’incipit mordace seguì un bel discorso tanto dadaista quanto pacifista. La «Deutsche Zeitung» del 18 novembre 1918 informò così i suoi lettori: “Incidente nel duomo. Quando ieri l’alto prelato Dryander ha cominciato la messa, è stato interrotto da un uomo ben vestito di mezza età. Il disturbatore ha tenuto un breve discorso dall’alto della galleria, terminando con le parole: ‘Per noi Gesù Cristo è una pinzillacchera’. Coro di buu, molte donne sono scoppiate a piangere e il religioso si è nascosto il viso tra le mani. La comunità ha riaffermato in coro che ‘Forte rocca è il nostro Dio’ e l’uomo è stato buttato fuori dalla chiesa. L’autore della manovra di disturbo è stato identificato quale architetto Johannes Baader, l’Oberdada del Club Dada. Egli ha inviato una lettera ai giornali con quello che, a suo dire, è stato il testo pronunciato nel duomo: ‘Vi chiedo un attimo di attenzione. Cos’è Gesù Cristo per l’uomo malvagio? Gesù Cristo, per lui, è pinzillacchera’. Il baccano provocato da queste parole sarebbe la prova provata, a detta di Baader, della coscienza sporca degli uomini, che si sono sentiti punti nel vivo”.
Walter Mehring riporta anche l’aneddoto parlamentare, vissuto da Baader come una crociata. L’ineffabile architetto si conquistò un posto sulla tribuna appena sopra quella riservata alla stampa internazionale, e si presentò in loco armato di un sacco pieno di volantini che non esitò a far piovere sui giornalisti dopo l’esecuzione dell’inno nazionale. Anche in quel caso ci scappò la visita psichiatrica, e dire che lui voleva solo entrare in contatto con i capi di stato di tutto il mondo. Il testo del volantino era infatti l’“autocertificazione” che lui altri non era che il Presidente dell’Orbe Terracqueo, unita a una critica dell’istituzione repubblicana. I giornali titolarono a caratteri cubitali: “I dadaisti disturbano la prima assemblea nazionale tedesca!”
Nel febbraio del 1920 i dadaisti berlinesi andarono in tournée a Lipsia, Teplice e Praga. Gli organizzatori erano Richard Huelsenbeck e Hausmann ai quali si aggiunse anche Baader, che si rivelò un’autentica spina nel fianco. A Praga l’atmosfera della vigilia era molto tesa, e in seguito al classico battage pubblicitario dadaista, ricorda Huelsenbeck nel libro Mit Witz, Licht und Grütze (1957) “la gente si aspettava davvero che piovessero vacche”. Tutta quell’attenzione spasmodica fece dare di volta al cervello a Baader. L’appuntamento praghese era fissato per le otto di sera, e mezz’ora prima dell’inizio nessuno sapeva più dove fosse. Huelsenbeck chiese lumi a Hausmann, il quale disse che Baader gli aveva lasciato un biglietto in cui diceva di dover fare un salto alla posta. Alle 20:20 dell’Oberdada non c’era ancora traccia, e i due poveri artisti dovettero affrontare da soli un pubblico massiccio e imbufalito. Baader aveva tagliato la corda portandosi con sé metà dei manoscritti utili alla serata. Non passò molto tempo prima che sull’Almanacco ufficiale Dada comparisse un articolo di fuoco contro l’Oberdada, in cui si lamentava la presenza nel movimento di soggetti pronti a sfruttare a meri fini pecuniari l’idea scardinante che aveva preso forma a Zurigo nel 1916 per mano di Ball, Tzara e Huelsenbeck. Baader, ad esempio, “non si sa se architetto, sartino o aiuto parrucchiere, comunque sia un pagliaccio borghese che dalla sua residenza nei sobborghi berlinesi si danna a scrivere diari e appelli rivolti all’umanità e ad altre personalità immaginarie. Come abbia fatto il signor Baader ad arrivare fino al dadaismo non lo sa nemmeno lui. Baader è un piccolo borghese imbullonato nelle questioni di chiesa, un Kurt Schwitters acconciato come il messia, un cervellino dilettante con mutande cosmiche”. E così via salmodiando. Baader non si prese la briga di rispondere a queste accuse. I suoi contributi all’almanacco parlavano da soli. Anzi, nel corso del 1919 era stato lui stesso ad annunciare al mondo la propria morte, e che con essa bisognava cominciare un nuovo conteggio degli anni…
Dopo lo strappo di Praga, Baader azzardò alcuni fallimentari tentativi di stampo dadaista. Da solo, come sempre. Nel 1921 tentò di organizzare un ballo di carnevale che attirò solo critiche sprezzanti, come un breve articolo sulla rivista d’avanguardia «Die Pille» che liquidò l’iniziativa nei termini di un necrologio Dada in cui le maschere servivano solo a celare la morte annunciata di un movimento allo stremo.
Raoul Hausmann diede una diversa interpretazione del tramonto del suo gruppo. “Dada aveva mancato il suo obiettivo. DADA, il tremendo cavallo di Troia carico di minacce, si era ormai ridotto a un tristo Ronzinante che la gente si vergognava a montare o anche solo a mostrare”. La fine di Dada rappresentò per Baader la fine dei riflettori. Una punizione che non colpì gli altri ex dadaisti. L’Oberdada tagliò tutti i ponti col movimento e nessuno si prese la briga di seguire le sue tracce, se si eccettuano un paio di lettere che scambiò con Hausmann. Mehring afferma di aver chiesto di lui ad Amburgo, ottenendo come risposta che ogni tanto lo si incrociava nei pressi del lago artificiale Binnenalster, ma che nessuno conosceva il suo indirizzo. Scrive Hans Richter: “Dopo lo scioglimento del dadaismo visse ancora, nessuno di noi sa dove, e morì sbarbato, a quanto pare rinsavito ma tornando di continuo col ricordo a quegli anni in cui il suo spirito monolitico lo aveva portato sull’orlo della follia, rendendolo membro di un gruppo degno di lui. Morì completamente tagliato fuori dal mondo, e dalla società che a suo tempo aveva infiammato, in un ospizio tedesco”.
Anche la data di morte è incerta. Pare che Mehring, mentre scriveva le sue memorie sul dadaismo berlinese, abbia ricevuto l’improvvisa notizia che Baader avesse reso l’anima a dio. Correva il 1958. Hausmann fissa invece al gennaio del 1956 il decesso di Baader, “a 80 anni, in un ospizio nel sud della Germania”, anche se con tutta probabilità il trapasso era già avvenuto il 15 gennaio 1955. Sull’«Hamburger Abendblatt», di cui Baader era stato collaboratore tra i tardi anni Venti e i primi anni Trenta, era apparso addirittura un lungo necrologio a firma Hans Harbeck, dal titolo È morto Baader ‘l’Oberdada’: filosofo o buffone? Grazie a questo pezzo veniamo a sapere che dopo il 1926 Baader si era ritirato ad Amburgo, e lì era rimasto finché le bombe non gli avevano fatto crollare il tetto sulla testa. Harbeck ricorda inoltre di averlo incontrato in occasione di una matinée agli Hamburger Kammerspeiele durante la quale avevano spezzato una lancia a favore del dadaismo, lui come storico e autore satirico, Baader in qualità di “filosofo e profeta”. Resta una lunga serie di anni grigi e poco documentati, sui quali getta un flebile fascio di luce la dadaista Hannah Höch. È lei, nelle sue memorie, a comunicarci il presumibile, penultimo domicilio conosciuto dell’Oberdada e a realizzarne un ultimo, toccante ritratto: “Emanava la quiete, la pensosità e l’umanità che a volte ho colto in Hausmann, ed era proprio lui a chiamarlo (senza offesa[1]) il messaggero celeste di Schussenried. Pensavo fosse un luogo di fantasia, e invece ora lo conosco: Schussenried, CAP 7953”.[2]
[1] La Schussenrieder è una marca di birra.
[2] Il nome corretto del luogo è Bad Schussenried, nel Land del Baden-Würrtemberg. La discrepanza geografica tra questo luogo e il presunto luogo di morte dell’Oberdada, Adldorf, in Baviera, è un’ulteriore conferma di come ogni serio proposito biografico nei suoi confronti sia destinato a fallire miseramente.


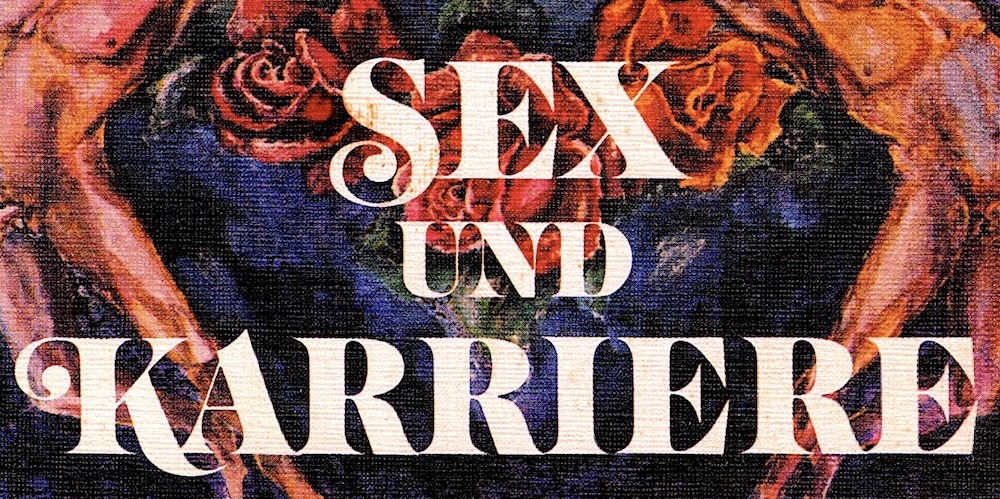


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.