
All’università, insieme alle mie compagne di corso, ho lanciato un blog dal titolo Polska nad Szprewą – la Polonia sulla Sprea. Lì parlo del festival cinematografico berlinese FilmPolska, della libreria antiquaria di Álvaro, del film Possession (1981) di Andrzej Żuławski e del monumento ai caduti antifascisti polacchi situato nel Volkspark del mio quartiere, Friedrichshain. Il blog è in polacco. Da qualche giorno ho in tasca il livello B2.
L’idea folle di tornare all’università, matricola, lezioni e tutto, a quaranta e passa anni – ormai più cinquanta che quaranta – la ebbe mio marito nel gennaio del 2021. Da un lustro ormai frequentavo le lezioni di polacco della Volkshochschule, con un’insegnante turbo appassionata di James Bond e Peaches. Formalmente ero già al B e qualcosa, ma mi mancava la pressione adrenalinica di un esame vero da sostenere. Sapevo peraltro che non avrei mai superato un esame orale. Le lezioni erano poco frequenti, informali, di fatto hobbistiche. Una delle prime cose che imparai il 10 ottobre 2015, prima lezione di polacco e giorno in cui incontrai Yassien, è che hobby, po polsku, si può pronunciare scandendo la doppia b: hobbəbbə. Un dettaglio che mi fece detonare la capa. Glielo raccontai, a Yassien, dopo meno di cinque minuti dalla nostra stretta di mano. Il resto è matrimonio.
Così, nell’estate del 2021, con la fisarmonica del coronavirus che andava allentandosi, inviai tutti gli incartamenti alla Humboldt, e attesi. Terrorizzato. All’idea che non mi prendessero, sancendo così un fallimento anagrafico insanabile. O che mi prendessero, ufficializzando un passo forse più lungo della gamba. Nel formulario ufficiale avevo chiesto di fare lo studente part-time al venticinque percento. Quando studiavo a Bologna a cavallo del millennio avevo sogni ricorrenti su esami non dati, nel senso che passavano i decenni e continuavo a dimenticarmi di darli. Un sogno ricorrente simile, maturato più tardi ma che ho ancora adesso, riguarda una miserabile stanza d’albergo condivisa col coinquilino di quando vivevo per conto mio, sempre a Bologna. Grande come un dormitorio da ostello, trasandata e col legno dei letti scheggiato, questa stanza è a mio nome da tempo immemorabile ma nessuno la usa. Ogni tanto ci torno di soppiatto per godermi questo spazio libero, sebbene inutile come gli oggetti che vi giacciono sparpagliati. Il conto aumenta, nessuno lo salda mai. Ma basta andarsene lungo una scaletta a chiocciola, abbastanza svelti da non dare nell’occhio alla reception, per rispazzare il discorso sotto il tappeto. Insomma, l’incubo di non (voler) finire progetti con scadenze precise, iniziati in preda a slancio scavezzacollo. Figurarsi adesso, con un lavoro a tempo pieno per quanto flessibile, rimettersi sui banchi.
Mi presero. Il masterplan è fare un Bachelor, in teoria di tre anni, con Slavistica (Polonistica) in pole position e Scienze bibliotecarie e dell’informazione come materia accessoria. Tradotto: imparare solo cose nuove. A due anni da questa scelta che mi ha imposto di mettere in pausa qualsiasi forma di attivismo e volontariato, ho nove esami alle spalle e sono a un terzo dello schemino. Ricordo ancora il senso di stanchezza abissale dei primi mesi, la testa fritta che dopo le 22 riusciva a malapena a giocare a sbarazzino sul letto prima di chiudere baracca. Pur avendo già studiato all’Alma mater un quarto di secolo fa, e per cinque anni, previo un esame d’ammissione a crocette che doveva battezzare centocinquanta nomi a fronte di duemila candidati stipati in un capannone della fiera, malgrado questo, e il vecchio ordinamento, e la tesi, e alcuni esami da incubo come Diritto pubblico e Relazioni internazionali, da quando studio in tedesco – e polacco – alla Humboldt mi sembra di fare l’università per la prima volta. Sarà che la memoria selettiva ha bruciato tutte le sequenze accademiche dei miei anni col villino in via Toffano a fungere da punto di riferimento della nostra setta di spietati analisti del tg4. Sarà, semplicemente, che a suo tempo avevo la sensazione di dover studiare per il pezzo di carta, mentre adesso questo lusso dadaista mi riempie di gioia. Una delle decisioni più azzeccate della mia vita.
Cosa c’è di più bello dello studio? C’è la struttura, istituzionale ma vispa, c’è il brivido della corsa al voto, c’è l’accesso a una quantità immane di conoscenza. Che non è lo stesso di una normale connessione a internet. Quando studiavo Comunicazione ottenni un rivoluzionario indirizzo mail e potei usare per la prima volta un computer connesso alla rete – occasione che sfruttai per vedere se a Nizza davano The Straight Story in anteprima europea (lo davano), per chattare col fidanzato via mirc sul canale #dadolandia, per scaricare i testi delle canzoni dei Blur e dei Queen e anche per visitare qualche pagina birichina, cosa che mi drogò d’avventura e vergogna. Ovviamente non sapevo dell’esistenza della cronologia. Oggi l’affiliazione universitaria consente di accedere legalmente a milioni di pdf, e oltre alla mail di rito, alla VPN fattapposta e a una connessione wireless valida in ogni dove (ci sia una struttura accademica) tutto funziona via moodle, una “piattaforma di apprendimento” che di fatto sostituisce dazebao, appunti, fotocopie e libri ordinati in via Petroni. Non succede quasi mai che sia necessario acquistare un testo. Le lezioni, una volta esperite dal vivo, si tramutano magicamente in versioni pdf di power point. Tutto è digitale, ordinato e organizzato alla perfezione. Con un ritmo pazzesco e un workload poderoso. Ma ordinato. E se questi commenti fanno di me un boomer, so be it.
Il progetto originario era di approfittare del “duales Studium” per domare il polacco – quindi iniziare a tradurre nella combinazione PL>IT – e avere credenziali da bibliotecario, un lavoro per cui in Prussia c’è molta richiesta. Le notifiche sulle posizioni che si aprono su Berlino le ho già attivate. Sul primo punto, per il polacco sto ricevendo una formazione universitaria che per il tedesco, imparato individualmente e crudamente più con la biografia che col curriculum, non ho mai avuto. Noi traduttrici vogliamo solo tradurre e spesso respingiamo proposte di interpretariato perché non ci competono – sebbene molte di noi abbiano eccome le competenze. Nel 2021 entrai in una saletta per il corso di polacco A2+ – primo step per chi comincia con conoscenze pregresse – e mi ritrovai per novanta minuti ad ascoltare un docente che parlava solo in polacco, a velocità di crociera, ci dava istruzioni in polacco e pretendeva da noi che parlassimo, argomentassimo, scrivessimo in polacco. E sì, leggessimo. Ma il leggessimo era, ed è, solo un quarto delle competenze richieste, funzionale alla produzione di chiacchiere comprensibili e di testi sensati oltre che ben strutturati. Quando nel corso del terzo semestre abbiamo iniziato a leggere i racconti di Tokarczuk e ho scoperto Sławomir Mrożek mi sono commosso. La Polonia non è solo croci mariane infiocchettate in aperta campagna, kaczyńskismo a palla e americanismo militarizzato. C’è una tradizione culturale impressionante che parte come minimo dai tempi di Mickiewicz e arriva intatta, oltre che poco approfondita all’estero, fino ai giorni nostri. Per farsi un’idea a colpo d’occhio dico sempre che basta guardare i poster dei film rifatti per il mercato polacco, una sorta di détournement programmatico con decenni di storia, che la dice lunga sullo światopogląd (Weltanschauung) di questo Paese abituato a mancare sulla cartina. Quanto al perché a monte, cioè perché studiare una lingua slava con sette casi e una dubbia reputazione politica, potrei raccontare di viaggi selvaggi a Oświęcim e Łódź o della distanza abissale tra Görlitz e Zgorzelec (che sono la stessa città), ma la spiegazione migliore l’ha data un nostro amico psicanalista. Polonia suona come Bononia.
In questi due anni ho imparato cose che non avrei mai detto. La meraviglia dell’Open Access, un’autentica rivoluzione copernicana nell’accesso alla scienza, pur perfettibile nel suo sistema di finanziamento, e il problema sindacalissimo, di fatto ancora intonso, della gratuità della peer review. Il portentoso ginepraio di RDA, il sistema internazionale di catalogazione bibliotecaria vigente da alcuni anni – un set di regole in costante sviluppo. La trascrizione fonetica, quanto di più lontano dal mio approccio visivo al mondo, eppure bellissimo coi suoi simboli assurdi e la mappatura che cambia a seconda delle lingue. Non capirò mai perché una t è dentale (quindi con un ponticello sotto) davanti alle vocali o alla cappa, alveolare davanti alle alveolari e postalveolare (con un trattino sotto) davanti alle postalveolari, ma va bene anche così. Alcune cose vanno imparate a memoria, in un tunnel di ossessione e disperazione, e dopo il picco dell’esame scemano, acquistano improvvisamente senso o restano un aneddotto – come la pronuncia di hobby.
Per capire meglio il fenomeno propagandistico e culturale del socrealizm, il realismo socialista alla polacca, qualche settimana fa abbiamo guardato il film Przygoda na Mariensztacie (1953) di Leonard Buczkowski (Leonarda Buczkowskiego, il genitivo è questo). “Avventura a Mariensztat” è un finto musicarello, nonché finta commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Varsavia protagonista negli anni Cinquanta di un importante rilancio urbanistico. Per la Polonia col sol dell’avvenire davanti alla faccia era il momento di costruire in tempi record nuovi quartieri, o intere città satellite come Nowa Huta, cantata peraltro da Wisława Szymborska nella prima fase, organica, della sua produzione. La protagonista, Hanka (Lidia Korsakówna), scopre Mariensztat venendo in torpedone dai campi insieme al suo coro contadino e decide di diventare muratrice a tutti i costi – non facile, sebbene il sistema promuova ufficialmente la parità dei sessi. Ce la fa, anche se più che un trionfo delle brigate femminili il finale segna l’importanza del lavoro collettivo e la saggezza del segretario locale del partito. Nel film c’è un’esile trama sentimentale che funge da McGuffin per lanciarsi a testa bassa tra le impalcature. L’altro McGuffin sono le canzoncine, che scompaiono appena si entra nel vivo. Hanka s’imbatte in un aitante muratore, la scintilla scatta, nella folla si separano senza dirsi come si chiamano, lei lo rintraccia – il faccione del tipo compare su un manifesto dedicato agli operai più zelanti – e i due si rincorrono nel viavai di calcina e scale mobili della Varsavia in crescita verticale, incrociandosi con sorrisi smaglianti dopo una lunga sequenza affamata di desiderio. Ed eccoli finalmente insieme. Che fanno i due piccioncini? Si danno la mano. Łał!


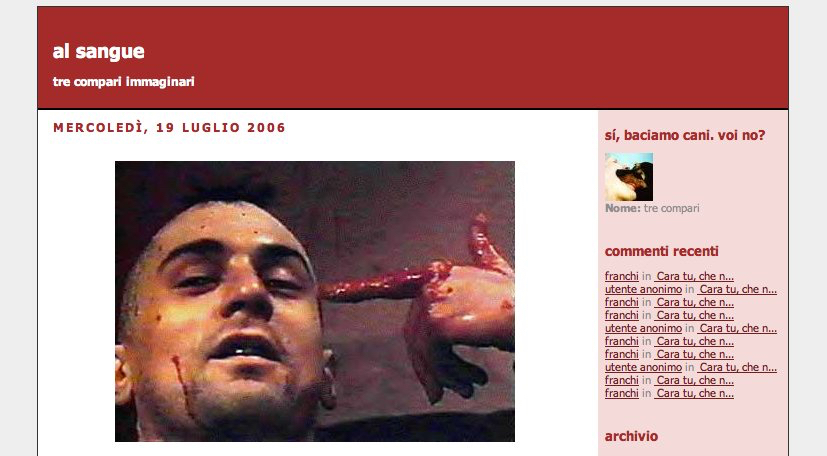
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.