
Tra i segreti meglio custoditi della letteratura germanofona contemporanea c’è il fatto che Thomas Melle è un genio a corrente alternata. Non perché sia bipolare, diagnosi devastante che alimenta la parte migliore della sua bibliografia, ma per il semplice motivo che ci sono libri belli, bellissimi con la sua firma e altri, non brutti ma trascurabili, con la medesima firma. Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, senonché i libri bellissimi sono ancora inediti in Italia. Qui parlo di due di questi, libri gemelli grondanti sofferenza e speranza, si chiamano Die Welt im Rücken (il mondo sul groppone) e Haus zur Sonne (la casa esposta al sole). Entrambi arrivati nella cinquina del Deutscher Buchpreis, e magari “Haus”, quest’anno, ce la farà, scaraventando il buon Thomas su un bel numero di scrivanie non tedesche.
Quando partecipai all’Internationales Übersetzertreffen nel 2017 all’LCB berlinese, il titolo di quella settimana di workshop e networking traduttivo era proprio Die Welt im Rücken, con Melle ospite d’onore. Mi innamorai durante la sua lettura a voce alta di alcuni passi, con un finale da singhiozzo. Gli dissi che era riuscito a canalizzare un’idea non facile, a tratti impensabile come la morte, cioè la convivenza con una patologia cronica, anzi più che la convivenza un abbraccio incondizionato, compresa la militarizzazione – in senso buono – della malattia in forma di letteratura. Mi lasciai andare a un paragone con gli inizi dell’hiv, in testa più il blu jarmaniano che un qualche corrispettivo letterario. Ricordo la bocca secca alla fine del mio intervento. Melle annuì, mi firmò la copia, ed eccola qui, sulla scrivania, riletta di fresco per prepararmi alla Casa al sole.
Il prologo del Mondo sul groppone recita: “Ich möchte Ihnen von einem Verlust berichten. Es geht um meine Bibliothek. Es gibt diese Bibliothek nicht mehr. Ich habe sie verloren”. Dopodiché, con questo gancio nelle carni, non c’è modo di appoggiare il libro prima di pagina 348. Sempre che apprezziate gli ottovolanti. Perché se siete tipi apollinei da ecfrasi perenne no, Melle non fa per voi. Melle strattona, parte per la tangente, cade e riparte in quinta, spiazza e irrita, poi ti viene vicino e ti sussurra all’orecchio, ti commuove, e riparte, e rispiazza, e buonanotte ai suonatori. Il secondo capitoletto parla di quando ha fatto sesso con Madonna e Björk in quel di Kreuzberg, ovviamente nella sua testa, poi si salta al 1999, un altro balzo fino al 2006, al 2010, pezzi di diario, discettazioni musicali à la Nick Hornby, tanto internet, tanto riflettere sulla comunicazione in internet, aneddoti da far tremare i polsi, pensieri seri sulla malattia, altri rapidi e fuori controllo come una pallottola in uno scantinato pieno di tubi. Non tutto il romanzo tiene, ma è il carburante che lo anima a essere unico, più che nel suo genere (“ibrido”, “anfibio”, cose che sappiamo già) nella sua voce, quell’alchimia misteriosa che trasforma un libro in un auricolare con le tue iniziali sopra.
Die Welt im Rücken è un testamento sulla bipolarità, una preghiera scaramantica per farla finire schiaffandola sulla pagina. Per salvare non solo la propria biblioteca, ma tutto il resto – oggetti, salute, relazioni, reputazione – che finisce regolarmente maciullato dalle fasi di Raserei, quando la mania imperversa e tutto straccia, tutto consuma, anche il tempo. Anni interi di mania. Capitoletto 41 della parte sul 2010, testo: Bin ich nicht. Capitoletto 42, testo: Und wenn Sie wüssten, was da vorher stand. Eccezioni in un romanzo a cuore aperto che non teme di affrontare i temi in profondità, siano essi l’autodistruzione o la passione per Trent Reznor. Un romanzo berlinese, quello di Melle, insieme a David Wagner uno dei pochi capaci di trasmettere il senso di Kiez, di vita oscillante tra rione e metropoli che da sempre contraddistingue il paesone sulla Sprea.
A pagina 140, capitoletto 5 della parte sul 2006, si parla della Haus zur Sonne, idea di Melle per uno spettacolo teatrale (una delle sue occupazioni fisse). Questo è il germe del romanzo uscito poche settimane fa, il secondo dal 2017 dopo il dimenticabile Das leichte Leben (KiWi, 2022). Dimenticabile, trascurabile, come mai? Perché nella Vita facile Melle trama a tavolino azzardando una critica sociale con punte di maledettismo del tutto inefficaci. Funziona meglio, invece, un altro suo romanzo-romanzo, cioè 3000 Euro (2014), che parla di come un deficit finanziario – quello del titolo – riesca a far ruzzolare il protagonista ai piedi della piramide, rischiando di non rialzarsi più dai margini. Più che un plot di finzione pura, un’ipotesi fondata su esperienze vere raggranellate durante le manie. Anche Haus zur Sonne è fondamentalmente fiction, ma questa finzione narrativa si installa nel dispositivo ibrido di Die Welt im Rücken. Quindi sì, è un secondo libro dedicato alla sindrome bipolare, con episodi e riflessioni di un narratore in prima persona che può solo essere Melle. Lo scollamento con quella che possiamo chiamare realtà si verifica però alla prima pagina, quando il protagonista riceve una busta azzurrina e scintillante contenente la risposta positiva da parte della Haus zur Sonne. Una clinica per suicidi.
Come si sono affrettati a scrivere alcuni critici letterari tedeschi, nel libro c’è un lieto fine e dirlo non è uno spoiler. Sia pure psicosi delle ore 4:48, ma il sole sorge ancora. In effetti, Melle ci risparmia il bizzarro corto circuito provocato dalla eventuale dipartita del suo personaggio. A contare davvero è comunque la sua abilità di rendere credibile la rampa della trama, ovvero la decisione incrollabile del protagonista di farla finita – perché la malattia sta vincendo, le preghiere non sono servite, la prossima mania rischia di essere, se non l’ultima, insostenibile quanto a perdite, vergogna, depressione. Ecco allora che il libro decolla, con enorme coraggio, da dove eravamo rimasti col Mondo sul groppone, replicando almeno in parte quella struttura composita, e approda in una clinica fantascientifica, peraltro sovvenzionata dal Bund, che tratta coi guanti i suoi ospiti accompagnandoli fino alla Fine. Non mancano incontri clou tra i corridoi pulitissimi, e somministrazioni di sogni a occhi aperti fondate sui desideri dei pazienti. Un po’ Arancia meccanica, un po’ Qualcuno volò sul nido del cuculo, Haus zur Sonne è una mossa letteraria sul filo di lana con la cazzata sempre dietro l’angolo, salvata in corner dal serbatoio empatico di Melle, dalle cose vere, e da un finale non clamoroso sulla carta ma entusiasmante a leggersi. La vita va avanti.
“Das hier – wirklich weg?” si chiede il protagonista a pagina 244, prima crepa seria nel progetto di ammazzarsi per via istituzionale. Haus zur Sonne è un portentoso breve invito a rinviare il suicidio, senza argomenti giudicanti o sbandate retoriche penose. Il tema viene preso sul serio – e chi ha letto Die Welt im Rücken crede subito alla volontà del protagonista – e altrettanto seriamente viene sviluppato passo passo, firma dopo firma, colloquio medico dopo colloquio medico, finendo per “scegliere la vita”, come direbbe Renton, ma sapendo bene che la vita è tutt’altro che una casa baciata dal sole. Del resto, se così fosse, sai che noia. Ed è questo che rende così speciale Melle. Non l’attrazione per l’estremo, il provocatorio, il cinismo houellebecquiano, bensì un’accettazione dolorosa, assoluta e a occhi spalancati della condizione umana. Fragile, autodistruttiva, malata, geniale, e vivaddio.
[Di Thomas Melle in Italia è uscito solo Sicario (OR. Sickster) nel 2015, ed. Fandango, trad. Fabio Lucaferri].

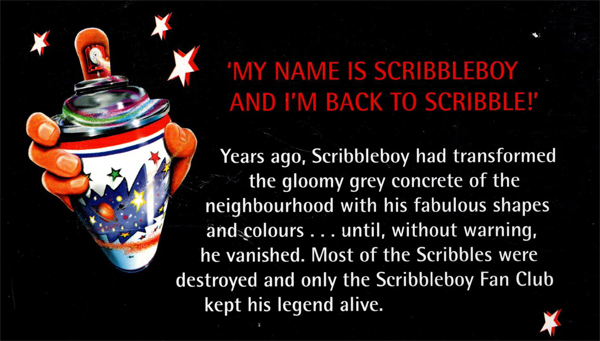
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.