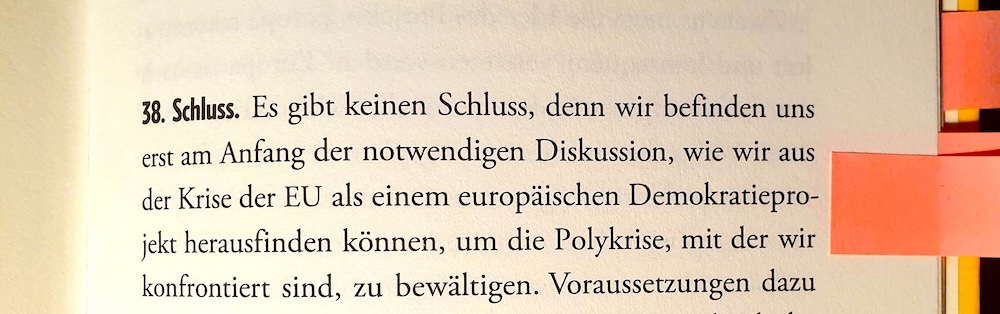
Trentotto tesine per l’Europa inchiodate su carta. Una in più rispetto al precedente pamphlet Der europäische Landbote, edito nel 2012 dalla viennese Zsolnay e riproposto da Herder nel 2015. Col titolo Un messaggero per l’Europa, sottotitolo La rabbia dei cittadini e la pace europea o Perché la democrazia regalata deve cedere il passo a una conquistata, il saggetto di Robert Menasse è uscito per Sellerio esattamente cinque anni fa con la mia traduzione. Ora, di nuovo sotto elezioni, Menasse esce in paso doble: in ambito germanofono con un nuovo libello a tesi, Die Welt von morgen (Suhrkamp), e da noi sempre per Sellerio L’allargamento, il suo secondo romanzo a sfondo UE dopo La capitale (2017). Traduzione, in entrambi i frangenti narrativi, di Marina Pugliano e Valentina Tortelli. Consiglio di cuor.
Qui però si parla del mondo di domani, che è già di quello di oggi, a ridosso e non solo delle elezioni europee. Se col Messaggero Menasse riffava Büchner e il messaggero assiano del 1834, stavolta il richiamo evidente è a Zweig e al suo Mondo di ieri, uscito postumo nel 1942 e noto alle giovani generazioni soprattutto come fonte ufficiosa del Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. In realtà, come si evince dalle primissime pagine, Menasse chiama in causa un altro pamphlet vibrante e velenoso come piacerebbe a Guccini, Der europäische Niemand (1719). Questo Ulisse settecentesco, questo nessuno anonimo ma svelto di lingua, collima grossomodo con lo Jedermann in senso positivo, l’uomo qualunque – non qualunquista – che ora come allora auspica un’Europa senza guerre, improntata ai diritti e all’armonia sociale. Menasse raddoppia anche in ambito saggistico per tracciare le linee dell’Europa che vogliamo.
Com’è questo Mondo di domani menassiano? Non molto diverso dal Messaggero pubblicato per la prima volta una dozzina d’anni fa, o dalla raccolta di discorsi Heimat ist die schönste Utopie – Reden (wir) über Europa uscita per Suhrkamp nel 2014. Perché malgrado le policrisi in aumento, l’Unione Europea post-Trattato di Lisbona non ha modificato di molto la propria impostazione politica. Certo, nel 2013 con la Croazia i membri sono diventati 28, poi di nuovo 27 causa Brexit, in mezzo ci sono passate la crisi dei rifugiati e la pandemia, e dal 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina le crisi vanno accatastandosi su più piani, dal geopolitico all’economico spiccio, per tacere della crisi climatica globale sullo sfondo. Tutto questo risuona come un’eco ferale nel saggio di Menasse, ma le tesi clou sono grossomodo le stesse.
Tesi numero 6, “Der Status quo”, p. 22. L’autore accusa la UE di scarsa fantasia, di non saper più cogliere nemmeno quella dei padri fondatori, e sottolinea come il primo nemico dell’Europa siano i politici con le traveggole, o meglio con la miopia tipica dei nazionalismi tutti staccionate e felpe campaniliste. Non è, purtroppo, una novità. Non è una novità che la UE, malgrado tutto, si stia sì sviluppando ma in una direzione sempre più distante dall’europeismo teorico e pratico del quarantennio tra la fine degli anni Cinquanta e l’introduzione dell’euro. Uno stallo che conosciamo bene e che risale perlomeno alla mancata ratifica della Costituzione europea nel 2005 da parte di Francia e Paesi Bassi. Due classici esempi di referendum à la Brexit ante litteram, quando cioè la politica pigra, invece di assumersi determinate responsabilità, delega la decisione “al popolo” alimentando, di fatto, una propaganda manichea. È la cifra del discorso pubblico degli ultimi trent’anni, col berlusconismo come matrice fotocopiata a iosa tanto da diventare ancor più buia e sbavata.
Menasse (p. 34) fissa un altro momento storico: le parole di Angela Merkel al Collegio d’Europa nel 2010, che in una fase di tensioni finanziarie e guerra di bilanci tra membri, finì per inaugurare la politica europea del minimo comun denominatore, abbassando l’asticella al livello del Consiglio Europeo. Tradotto: l’atteggiamento tedesco dei bei tempi merkeliani, belli perché floridi – e floridi per merito delle misure impopolari prese dal governo precedente – ha ulteriormente alimentato l’egoismo nazionalista. Ecco allora che a essere sovrana è sempre meno l’idea di un’Europa sovranazionale, post-nazionale, ombrello efficace e matria di tutti, e sempre più la scappatoia sovranista come abbiamo imparato a conoscerla.
La tesi numero otto (da p. 42) è dedicata alla cultura, ma quale cultura? Già nel Messaggero, Menasse scriveva alcune delle sue pagine più acuminate descrivendo il peso piuma del compartimento culturale nell’organigramma della UE. L’idea geniale, e provocatoria, alla base della Capitale è proprio quella di un rilancio simbolico dell’Europa mediante l’individuazione di una città – non Bruxelles! ma nemmeno una Brasilia nuova di trinca – che ne diventi il volto stellato. Chi ha letto il romanzo sa anche di quale città si tratta, e ci sono persino dei motivi storici antecedenti alla Seconda guerra mondiale. Menasse difende da un lato, senza sciocche nostalgie, la Mitteleuropa asburgica, dall’altro constata con orrore come la cultura sia sempre più importante nelle agende dei nuovi governi di estrema destra. Una cultura regressiva più che conservatrice, becera, revisionista e revanscista, come quella cavalcata dal PiS in Polonia o dal Sangiuliano de noantri. Per Menasse, austriaco, è relativamente facile ragionare in termini storici e culturali sovranazionali, quindi per intenderci di germanofonia e non di nazione austriaca, ma è proprio lo stereotipo dello stato-nazione culturalmente omogeneo a portare l’argomentazione al calor bianco.
La sua tesi principale (da p. 66) riguarda il superamento della nazione, e quindi del nazionalismo. Nation ist Fiktion, scriveva in Heimat ist die schönste Utopie. In sintesi, Menasse sostiene – fin dal Messaggero – che la forma statale a cui siamo abituati è un accidente della Storia, perfettibile e pieno di svantaggi. Svantaggio numero uno: le guerre per i confini nel nome di una bandiera. Tra le origini del nazionalismo moderno ci sarebbe peraltro una falsa interpretazione della dottrina Wilson sulla autodeterminazione dei popoli. Quello che propone Menasse è di fatto una disintermediazione radicale, cancellando lo st(r)ato nazionale e collegando direttamente i territori al grande ombrello europeo. Lui stesso ha proposto l’adozione di carte d’identità europee che riportino il luogo di nascita, la residenza ma non lo stato di appartenenza. Perché non possiamo non dirci europei. E i guai degli ultimi decenni hanno proprio a che fare con questa identità poco sentita, fragile, spesso avversata. Il Noi dei Delors e degli Schuman è diventato un Noi qui contro quelli là. Il paradosso dissonante del “Ce lo chiede l’Europa”.
L’alternativa caldeggiata da Menasse è un’Europa delle regioni. Ipotesi affascinante ma difficile da immaginarsi. Un po’ perché, almeno in ambito italiano, il regionalismo è sinonimo di Lega. Inoltre, in termini pragmatici, se l’Europa litiga a 27, immaginiamoci un’Europa della coesione a 281 – questo il numero ufficiale delle regioni riconosciute dalla UE. Detto ciò, Menasse sa sempre strappare un sorriso sghembo. Per smontare il nazionalismo tira in ballo (p. 96) un testo di Musil del 1923, Der deutsche Mensch als Symptom, che avrebbe dovuto intitolarsi Der deutsche Mensch als europäisches Symptom, e arriva ad assemblare un pastiche di inni nazionali (pp. 91-92) che suona come un poema horror. Di sangue, violenze e suolo son pieni i testi di tutti gli inni, senza nemmeno il bisogno di recuperare il vecchio Deutschland über alles.
Una buona sponda al saggio di Menasse la offre il volume a cura del Forum Disuguaglianze e Diversità, nelle persone di Elena Granaglia e Gloria Riva, appena uscito per Donzelli: Quale Europa – Capire, discutere, scegliere. Nel primo capitolo, Dove atterra il Parlamento europeo, scritto da Riva, si fa cenno a due “cenerentole” sottoutilizzate dalla UE, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale. Il capitolo sulla coesione, a firma Fabrizio Barca e Sabina De Luca, mette al centro il concetto di place-based definito come sensibilità nei confronti delle persone nei luoghi. Dai quali si parte, ai quali si arriva e ai quali, a volte, si torna. È uno dei cavalli di battaglia del Forum: ideare politiche di reale inclusione sociale che puntino alla riduzione dei divari, per esempio quello tra centro e periferia. Con la periferia che può anche essere una comunità montana. Non vi è dubbio che una buona politica di coesione possa sfociare in una sussidiarietà autentica e fruttuosa. Bisogna però prima svelenire i pozzi ideologici.
In Die Welt von morgen, così come nel Messaggero, Menasse torna sul macrotema dell’equilibrio di potere all’interno della UE. La sua tesi, condivisibilissima, è che il Consiglio Europeo abbia esautorato nei fatti la Commissione. Questa è una delle storture degli ultimi anni, proprio a partire dalla crisi dell’euro e dalla miopia del merkelismo: la primazia delle beghe nazionali rispetto al costrutto europeo di ordine superiore. Menasse vorrebbe per esempio che la presidenza della Commissione venisse decisa elettoralmente, quando si vota per il Parlamento, e non via trattative ex post. Un’idea ancora migliore, rilanciata da Gloria Riva in Quale Europa, è quella di liste davvero europee. Quindi non una croce su simboli locali, ma partiti realmente europei – le “famiglie” esistono già – con candidati internazionali. Bello ma impensabile in una fase che, almeno in Italia, interpreta il voto europeo come una mera esercitazione. Basterebbe poco per ripristinare la serietà di cui parla Romano Prodi da anni, ma logiche spicciole di concorrenza, della serie se la furbata la fa lui perché non dovrei farla anch’io, contribuiscono a una macchietta che sottrae ulteriore credibilità al meccanismo democratico. Il colmo, poi: votare parlamentari europei che l’Europa la vogliono smontare. Uno dei tanti serpenti dada che si mordono la coda al giorno d’oggi.
Parlando di corti circuiti e senso di smarrimento, Menasse nel suo nuovo saggio spende anche qualche parola sulle due principali crisi internazionali che stiamo vivendo. Nei confronti dell’Ucraina aggredita dimostra una certa freddezza, asserendo che il paese sotto attacco rischia di diventare ancora di più un calderone nazionalista, invece di un ottimo candidato UE, e che la guerra – va da sé – ha motivazioni non solo territoriali, ma anche economiche che fanno gola a molti (terre rare). Per quanto riguarda la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese, Menasse scrive cinque righe (p. 65) che rischiano di sabotare la diffusione del testo in quella che definirei la mia bolla. In sintesi, accusa la sinistra-sinistra di avere un feticcio per la Palestina, ignorando molte altre situazioni simili. “Uiguren aber: keine Erregung”. Il tema è ovviamente complesso, delicato e come si dice oggi divisivo, ma personalmente ritengo davvero che soprattutto negli ultimi anni quella che vuole chiamarsi sinistra, e che collima con un certo milieu culturale, abbia fatto due cose: ha difeso, consciamente o inconsciamente, regimi autoritari come la Russia, l’Iran e la Cina; ha riportato a galla l’antisemitismo travestendolo da antisionismo. E una terza: scagliandosi contro la Nato e l’Occidente in generale, ovvero lo spazio in cui questi discorsi riescono a svilupparsi, si è ideologizzata in chiave masochista e naïf. Soffriamo tutti di disorientamento, oltre che di una inferiore qualità di vita dovuta alle policrisi di cui sopra. Non basta tuttavia a giustificare un nuovo manicheismo trainato dal soft power e alimentato da fatti alternativi o selettivi (cioè, che ci piacciono). Detto questo, anche Menasse critica, con giusta ragione, l’ottica europea che continua a vedere nella Nato l’unico scudo in una fase di turbolenze molto serie.
Nel 1983 Milan Kundera pubblicò Un Occident kidnappé, il testo in cui rivendica la natura occidentale della Mitteleuropa finita dietro la cortina di ferro. Secondo Menasse, dopo la caduta del Muro l’Europa centrale è stata rapita una seconda volta – dai neoliberisti e dagli “zombi del nazionalismo” (p. 59). Molti dei problemi di coesione intra-UE hanno questa origine, e il 24 febbraio 2022 si spiega anche con la debolezza dell’Europa, la stanchezza della sua democrazia strapazzata. E dire, sostiene Menasse, che la UE ha delle eccellenze a livello mondiale come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’impostazione stessa dell’Unione è avanguardia allo stato puro, tanto da far impallidire quella degli Stati Uniti d’America che, seppur a fini di semplificazione, continua a venire ripresa dagli europeisti come meta da raggiungere.
Robert Menasse non vuole gli Stati Uniti d’Europa, ma una forma di governo nuova, post-nazionale e democratica, in Europa, in cui sciogliere tutti gli stati membri. Per me questa non è fantascienza, ma il credo laico col quale sono cresciuto negli anni Ottanta e Novanta. Senza l’Europa, pur nella sua forma provvisoria, con i tanti gradini che ancora si sentono di paese in paese, non sarei qui a scrivere quel che scrivo e a fare quel che faccio tutti i giorni. Sì, in termini metaforici alcuni scartamenti ferroviari sono ancora troppo diversi tra uno stato e l’altro dei 27. Ma la risposta non può essere uno splendido isolamento, perché l’isolamento non esiste più, anzi, è fallimento assicurato. Einheit in Vielfalt, scrive Menasse nell’ultima pagina del Mondo di domani. Una bella chiusa, che mitiga la cupaggine dell’ammissione, giocosa fino a un certo punto, di p. 81: “Ich bin kein Hellseher. Ich sehe schwarz”.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.