
Se Megalopolis è un corallo frattale, poroso e inafferrabile, l’ultimo film di William Friedkin è uno zippo compatto e scintillante, che fa quel che deve fare. Trasformarci le pupille in scintille. Il paragone è ovviamente non richiesto, ma è affascinante pensare al fatto che Coppola e Friedkin abbiano lavorato in contemporanea al loro ultimo lungometraggio, e che gli esiti siano così differenti. Di Megalopolis s’è fatto un gran parlare per decenni, a ridosso dell’uscita molto gossip, dopo l’uscita ogni cinefilo, dal videocassettaro al moderno letterboxdeur, ha detto la sua. Sul canto del cigno certificato di Friedkin, morto un mese prima del passaggio al Lido, poche reazioni e rare analisi approfondite.
Un possibile motivo è che il film non è uscito al cinema, parcheggiandosi subito su Paramount+ come produzione Showtime. Nei titoli di coda salta all’occhio che la sceneggiatura dello stesso Friedkin, tratta dal premio Pulitzer di Herman Wouk (1951), è accreditata come “teleplay”. Friedkin viene dal mezzo televisivo e non ha mai disdegnato occasionali ritorni, spesso alimentari, arrivando a ipotizzare, negli ultimi anni, persino una miniserie ispirata a To Live and Die in L.A. (1985). Formatosi nel documentario, e ottenendo un primo successo nel 1962 con The People vs. Paul Crump, nel 1965 con Off Season Friedkin diresse l’ultimo episodio dell’Alfred Hitchcock Hour. Il debutto industriale coincise con un musicarello di Sonny e Cher, cui seguirono un film tratto da Harold Pinter e l’allegra commedia di costume “artsy fartsy” The Night They Raided Minsky’s, scollacciato come poteva esserlo un film americano pre-sessantottino.
Per chi scrive, il capolavoro numero uno a firma Friedkin arriva nel 1970 con l’adattamento per lo schermo della pièce The Boys in the Band di Mart Crowley, film amarissimo sulla condizione omosessuale, oggi indubbiamente superato ma per molto tempo necessario come lo fu Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt (1971) di Rosa von Praunheim, esempio da manuale di cinema attivistico e volontariamente antipatico. Il punto di vista di Friedkin è sempre stato eterosessuale, “alleato” ma non direttamente coinvolto, e con Cruising (1980, capolavoro numero ics) riuscì nella non facile impresa di offendere la comunità e disgustare il pubblico generalista. Eppure, la distanza tra i due film, lo scarto siderale tra un Kammerspiel di compleanno e un mistero irrisolto nella scena BDSM newyorkese, riesce non solo, a posteriori, a tracciare la parabola degli anni Settanta, aperti da Stonewall e chiusi dal silenzioso diffondersi dell’AIDS, ma dimostra anche la crescita di Friedkin come regista macinageneri, sempre pronto a togliere tappeti da sotto i piedi, anche i propri, dilapidando in tempi record qualsiasi medaglia di credibilità. Un autoammutinamento. In termini di botteghino, Friedkin non ha mai ripetuto la doppietta French Connection-Exorcist, ma è proprio con Sorcerer (1977), remake del Salario della paura assurdamente camuffato, nel titolo e nelle primissime immagini, da sequel dell’Esorcista, che si coglie il suo andamento anguilloso e autenticamente ribelle. Scomodo e queer come un’arancia all’orologeria.
In televisione, Friedkin tornò già nel 1985 con un celebre episodio “tardo” della Twilight Zone, Nightcrawlers, che porta il Vietnam con poteri ESP in un americanissimo diner. Nel 1994 diresse uno dei titoli più improbabili della sua carriera, il film televisivo Jailbreakers con Shannen Doherty, solo per completisti, ma come ogni sua opera anche minore – vedi Rampage, o The Guardian – le zampate non mancano, e si ha sempre l’impressione che la storia cali su di noi come una scudisciata. Alla fine di The French Connection, il boss interpretato da Fernando Rey scompare nel nulla, vanificando gli sforzi di una polizia antropologicamente non molto diversa dalla mala. L’eroe o presunto tale di To Live and Die in L.A. crepa con la rapidità di Janet Leigh in Psycho, senza nemmeno beneficiare di un ultimo primo piano. Il trasferimento di Pazuzu nel giovane prete alla fine dell’Esorcista, in modo da eliminarlo rovinando giù per le scale, fu un compromesso. Friedkin ha sempre preferito le vicende zoppicanti, i finali aperti, il fallimento rispetto all’apoteosi. Lo si vede graficamente, in forma di burla, nell’ultimissima inquadratura della sghemba commedia militare Deal of the Century, e lo si legge nella chiusa della sua autobiografia The Friedkin Connection (2013), in cui il regista ammette di non aver fatto il proprio Citizen Kane, ma è questo che ama in quello che fa. “Forse fallirò di nuovo. La prossima volta fallirò meglio”.
E allora la sua famosa intervista a Fritz Lang del 1975, al culmine della fama, può essere vista non come un dialogo tra maniaci del controllo e della precisione, ma tra indagatori del male, esperti nello smascherare il lato oscuro di ogni società e individuo, senza tuttavia fornire panacee o cariche con squilli di tromba. Il dottor Mabuse come metafora universale, tentacolare e inestirpabile. Nicolas Winding Refn ha avuto la baldanza di ripetere il gioco con Friedkin nel 2015 intervistandolo su Sorcerer, arrivando ad autodefinirsi suo delfino. La reazione di Friedkin, tra il divertito e il corrosivo, è uno dei motivi per cui ci si può tranquillamente avvicinare ai suoi film passando per il personaggio, un metodo consentito da pochi giganti del gigioneggiamento come Hitchcock o Herzog. Altro video imperdibile: Friedkin, autore di uno degli horror più importanti di sempre, che incorona Tobe Hooper e il suo debutto in 16mm Texas Chain Saw Massacre (1974).
C’è però un filone friedkiniano che salta a piè pari la dimensione dell’incompiuto inquietante, del tappeto tirato via. Si tratta spesso di lavori su commissione, come i solidi Rules of Engagement (2000) e The Hunted (2003), o il remake televisivo di Twelve Angry Men (1997). È in questo alveo che rientra anche l’ultimo The Caine Mutiny Court-Martial, fondendo la claustrofobia e i dialoghi al fulmicotone del classico di Reginald Rose e Sydney Lumet all’atmosfera in divisa del courtroom drama anno 2000, che avrebbe potuto benissimo recare la firma di Eastwood. Qui Friedkin dimostra di saper dirigere senza sbavare, concentrando in quattro pareti la sua analisi spietata dell’essere umano, delle fandonie in cui crede, che dirama e di cui è mero strumento. Il film ha un impianto granitico e termina con un ceffone – figurato: evito spoiler – che serra la trama, chiude i conti dei personaggi e ci arriva in fronte come un’onda sismica. Il male, ancora, ineluttabile e serpeggiante, stavolta nella forma di una giustizia ingiusta in cui anche noi abbiamo creduto.
Chi conosce il testo originale e ha visto il film del 1954 di Edward Dmytryk, con Bogart nei panni dello psicotico capitano Queeg, sa già dove si va a parare. Anche Robert Altman ha adattato la pièce nel 1988. Friedkin aggiorna il materiale portando la nave dal Pacifico al Golfo, ci aggiunge un tocco di internet a bordo e abbraccia in pieno il genere del legal drama militaresco, senza alcuna scena girata in esterni, tanto meno flashback tra i flutti. Il contrasto con la follia allucinata di Bug (2006), la maramalderia di Killer Joe (2012) o il protodocumentarismo di The Devil and Father Amorth (2017), demoniaco e demenziale nel suggerire come anche l’Esorcista sia a suo modo un documentario, è quanto di più netto. Nel ping pong delle testimonianze, delle teste parlanti, delle psicologie definite passo passo, l’ultimo film di Friedkin è un capolavoro drammaturgico che fa impallidire pur ottimi film come i succitati Bug e Killer Joe, entrambi adattati (e sceneggiati) da Tracy Letts. La svolta reazionaria nel finale, farina del sacco di Wouk, è uno specchietto per le allodole riconducibile al genere bellico. Il tema vero resta la necessità di grattare la superficie, sapendo che non ne salterà fuori nulla di buono. Giustizia non è fatta, perché la verità sfugge.
Con The People vs. Paul Crump, William Friedkin salvò la vita di un uomo. In molti dei suoi film successivi questa forza edificante del cinema che cambia e migliora la realtà si trasforma in un’indagine dolente sulla pervasività del maligno. The Caine Mutiny Court-Martial, così inattuale col suo status di ennesimo adattamento, con le sue atmosfere impettite, i personaggi quasi sempre seduti e scuri in volto, torna a uno schema impeccabile, rinuncia a vuoti abissali e scivoloni, e ci consegna un dossier agghiacciante, ma almeno definitivo, sulla nostra anima rotta.



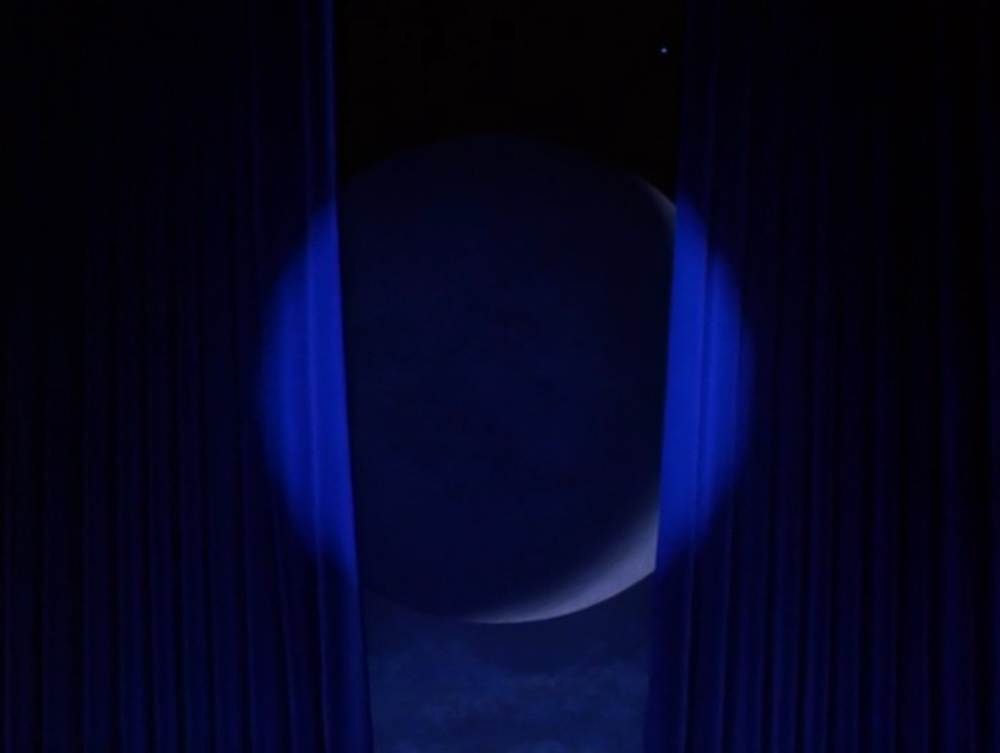


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.