Julia Ducournau, classe 1983, ha vinto il festival di Cannes portandosi a casa – per la prima volta nella storia – una Palma d’oro tutta per sé. Nel 1993 Jane Campion aveva dovuto smezzarla con Chen Kaige. A sconvolgere in positivo non è solo la decisione della giuria (che arriva con mostruoso ritardo rispetto al resto della galassia), ma anche e soprattutto il fatto che Ducournau consideri The Texas Chainsaw Massacre un capolavoro. È una di noi. La maledizione dei Dardenne e dei Bille August pare finalmente esorcizzata.
Titane, per ora, è solo un trailer o una visione per pochi eletti. Sono invece disponibili le prime fatiche di Ducournau, vale a dire il corto Junior e Grave (titolo internazionale: Raw), disponibile su Amazon Prime. Va detto che Raw non traduce Grave, e grave significa grave, tant’è che nel film la protagonista a un certo punto afferma “C’est grave” prima di montare il compagno di stanza. Il titolo inglese cerca la scorciatoia per riferirsi al tema della pellicola, vale a dire il cannibalismo.
L’autrice è sinceramente affascinata e attratta dal binomio natura/cultura, dal cortocircuito tra il biologico e l’innaturale, tra l’istinto e il “contro natura” (inesistente). Uno degli aggettivi che usa più volentieri parlando dei film horror prediletti e in particolare di Cronenberg è “organico”. Come sottolinea Michele Faggi nella sua articolata recensione di Grave, non siamo certo dalle parti di Deodato. Cannibali non sono gli altri, i selvaggi, cannibale è la protagonista Justine (Garance Marillier), cannibale [spoiler] è la sua famiglia da parte di madre [fine spoiler], cannibali siamo noi spettatori. La prospettiva include, non tira linee. Non c’è othering, piuttosto una enorme schwa sul quale fa perno tutta la potenza divorante del film.
Ari Aster ha girato Hereditary un anno dopo Grave, che forte di questo vantaggio si qualifica come uno degli horror moderni più coraggiosi nello spostare l’origine del tabù all’interno della famiglia. Ma dai primi film di Ducournau emerge soprattutto un elemento di body horror che è impossibile non ricollegare a Cronenberg e al suo approccio accademico al genere truculento. Junior (sempre Marillier) è una maschiaccia in piena metamorfosi… destinata a uscire dal bozzolo in forma di leggiadra femminuccia. Non prima di essersi squamata, letteralmente spellata come una matrioska di carne, e aver secreto nel processo una sorta di liquido acquoso. In Grave, le prime disavventure di Justine, nomen omen, comprendono un’eruzione cutanea con prurito al cubo. Più tardi fisserà il suo compagno di stanza intento a giocare a calcio con uno sguardo da Alex in Arancia meccanica, e il sangue al naso. La protagonista di Titane, a quanto pare, perde olio motore dopo essere stata messa incinta da una Cadillac. Corpi femminili in transito verso corpi nuovi, nuove prese di coscienza.
L’aggancio di Ducournau con Cronenberg senior è indubbio. Nel video in cui pesca i dvd preferiti, la regista confessa di piangere ogni volta che vede La mosca. Sono i tic di Goldblum sotto il mascherone, le sue riflessioni a freddo sull’essere uomo & insetto a colpirla. Come i bimbi di The Brood, o l’eccitazione per il metallo e i cerchioni in Crash. Nulla di nuovo per l’appunto, ma erano anni che lo sguardo di Cronenberg sul mondo organico e le sue pulsioni non veniva ripreso con tale efficacia. Lo stesso Brandon Cronenberg, con Antiviral (2012) e soprattutto con l’eccellente Possessor (2020), non disdegna l’idea del body horror ma tende a spostarlo a un livello cerebrale, con immagini astratte più vicine a Under the Skin che ai classici del padre. Ducournau, dal canto suo, ama i flash sulla carne putrefatta che aprono il film di Tobe Hooper (e in Grave li scimmiotta, facendo vagare le due protagoniste nel ripostiglio della facoltà), ama Drag Me to Hell (2009) di Sam Raimi e la sua choccante sincronia con la strega invece che con la protagonista, ama il Cronenberg di genere – e apprezza pure certe zampate di James Wan.
Grave riesce comunque a divincolarsi dall’accusa di prodotto derivato. Julia Ducournau sceglie di ambientare il film tra i casermoni di una facoltà di Veterinaria non dissimili dagli edifici che si vedono nei primi due film di Cronenberg, ma la messa in scena genera un immaginario a sé stante, contraddistinto da quadri puliti, campi lunghi rivelatori, una nettezza che non si scompone nemmeno quando piovono secchiate di sangue (omaggio a Carrie) o ne vengono lanciate di vernice blu (anticamera a una scena originalissima). Forse il film regge meno quando pizzica le corde nerd di Welcome to the Dollhouse (1995), e soprattutto nel proporre uno strano zigzag nell’orientamento sessuale del coprotagonista maschile (Rabah Naït Oufella). L’elemento familista è invece scardinante, e per certi versi fa risuonare di più il mondo di Bellocchio rispetto al cinema di genere. Certo, con Sangue del mio sangue (2015) lo stesso regista piacentino aveva messo in chiaro che anche lui, volendo, può parlar di vampiri. Ma il Bellocchio virale è quello della famiglia come destino e buco nero, linfa e veleno. Grave gravita a queste latitudini.
L’ultima inquadratura di Raw è Cronenberg allo stato puro. Una camicia che si apre, e rivela. Immagine casalinga, innocua anche perché inscenata al tavolo della colazione, ma capace di evocare sia la svestizione di Samantha Eggar in The Brood, sia quella di Roy Scheider nel Pasto nudo (1991). Vedremo, in Titane, quanto c’è di ballardiano, quanto di Winding Refn, quanto di Tsukamoto – nella speranza che non ci sia nulla di tutto questo. Che Julia Ducournau continui invece a mangiarci con gli occhi.




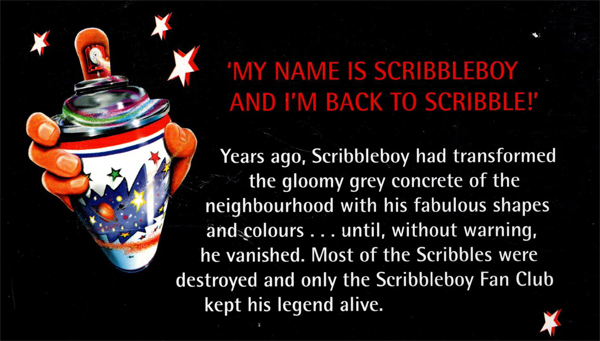
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.