
“Molti troveranno i miei film cinici e dilettantistici. Sono noto per farmi beffe dei miei attori. Il mio racconto autobiografico sarà considerato superficiale e pornografico. È schifosamente privato e proprio per questo motivo mi interessa renderlo pubblico, poiché al mondo ci sono un sacco di troie frocie e una società che crede sempre di essere migliore di loro. Non ci restano che autoconsapevolezza e orgoglio”.
Questo colpo di scudiscio è la stringata prefazione del libro-non-libro Sex und Karriere, uscito nel 1976 e inedito in Italia. Più che un libro, un catalogo egomaniaco, una filmografia completa di sinossi e specifiche tecniche per un autore attivo da meno di dieci anni, già prolifico ma sicuramente non ancora pronto per essere musealizzato. Rosa, va da sé, era di diverso avviso. Il volumetto contiene qualche riflessione sull’impatto di Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt (1971), tuttora il suo film più influente, un’ottantina di pagine infarcite di immagini e documenti battuti a macchina di questo benedetto resoconto autobiografico steso a New York nell’inverno 1975/76, interessante solo per completisti, e il resto è una congerie di scartoffie e articoli di giornale a corredo della filmografia. Una trentina di titoli. Rosa von Praunheim è morto pochi giorni fa chiudendo un’opera inarrestabile e difficilmente scontornabile di oltre 150 film, per tacer del resto.
Tutti, nel mondo germanofono, sanno chi è e si sono sentiti a disagio almeno una volta per via delle sue dichiarazioni. Fuori dalla Germania, e fuori dalla bolla cinefila, Rosa stinge. Il primo mediometraggio che vidi, Can I Be Your Bratwurst, Please? (1999), protagonista Jeff Stryker e girato in Ammeriga, è un inganno. Diverte, è camp, sembra un John Waters ripulito o un porno soft col freno a mano, ma gli manca l’energia grezza, l’orgogliosa approssimazione tipica di Rosa, che quando per un breve periodo ebbe una relazione con Werner Schroeter generò un clamoroso ossimoro stilistico. I film di Rosa sono svelti, brutti e cattivi, spesso contenutisticamente opinabili o volontariamente grossolani nella loro argomentazione. Non gli è mai interessato raffinarsi, da barricadero com’ era di un’idea di attivismo personale, fin troppo innamorato di New York (oggi si direbbe escapismo, esotismo, provincialismo puro) ma così tedesco da essere interessante di rimbalzo. La Germania ha in Rosa una figura monumentale che non tutti i Paesi hanno.
Grandioso, Rosa, lo è sempre stato nella cura della propria immagine, una sorta di Carmelo Bene del popolo, un Aldo Busi che vive sul palcoscenico del Costanzo Show. Leggendari i suoi cappelli, le sue mise da spettacolaccio del sabato sera, ma anche la nonchalance con la quale andava in giro per la Berlinale come un Holger qualsiasi (all’anagrafe è Holger), senza copricapi né colori sgargianti. Rosa c’era sempre. Rosa di Praunheim, quartiere francofortino, ha lasciato una traccia indelebile nel discorso pubblico tedesco, tematizzando la “condizione omosessuale” senza far sconti a nessuno, soprattutto a noi omosessuali, abbracciando le misure di prevenzione durante la crisi dell’AIDS in maniera ancora più radicale di chi, di prevenzione, si occupa davvero (e pestando, nel farlo, un paio di grosse merde bilanciate dalle migliori intenzioni), schiacciando il pedale sul fronte della visibilità con la sua famosa, sgarbatissima azione di outing di personaggi noti, e infine fungendo da mentore per i suoi Rosakinder – Chris Kraus, Axel Ranisch, Julia von Heinz, Robert Thalheim, Tom Tykwer. Talenti diversi che sono riusciti ad affermarsi grazie ai consigli pratici di Rosa, a partire dalla regola d’oro della messinscena: esporre, mettere in difficoltà, documentare lo scontro.
La ridda di film di finzione, documentari, ibridi, corti e cortissimi, casalinghi e a zero budget firmati Rosa è un getto d’acqua color arcobaleno con la potenza di un idrante. Ti stende, e non sai esattamente cosa ti ha steso. Mettersi lì a voler studiare tutto rischia di essere una strategia punitiva. Il suo merito risiede più che altro nell’approccio maturato in quasi sessant’anni di attività, ovvero la compilazione di un’enciclopedia vecchio stampo del’immaginario e del pantheon LGBTQ made in Germany. Scremando le molte cose girate allo specchio, come l’ultimo, inguardabile Satanische Sau, conviene leggere Rosa come un cronista che incontra un Mario Wirz sfinito ma mai sconfitto, punzecchia Ralf König, indaga il mondo della prostituzione maschile a Berlino Ovest o tenta di raccontare la biografia di Magnus Hirschfeld. Con uno sguardo, questo sì, rimasto intatto da decenni: molto occidentale (nel senso di Berlino), estremamente GLBT (con L e T minoritarie) e convinto che basti la sfacciataggine per far funzionare un film. Da avanguardia scomoda, col passare del tempo Rosa è diventato una statua equestre vivente. Forse inevitabile. E peccato che nessun*, almeno in Germania, sia riuscito a riempire i vuoti. Ma se si parla di cultura frocia, Rosa ha scritto la Treccani e se l’è cucita addosso. A noi il compito di sfogliare prendendo appunti.
Il cuore della mostra autocelebrativa allestita a Berlino Ovest sul finire del 2012, Rosen haben Dornen (le rose hanno le spine), era un fantoccio di Rosa steso in posizione da salma su fondo nero, con tre cappelli che gli fluttuano sopra a mo’ di angeli. La morte di Rosa, questo il titolo. Da ipocondriaco furente che era, tanto da fare un film sulla propria ipocondria, Rosa è riuscito a superare indenne due pandemie e a fare tutto quel che voleva, compreso un romanzo, compresi dei disegnini incorniciati ed esposti in gallerie bene. Proprio in una di queste ultime occasioni sono riuscito a parlargli, porgendogli una rosa – fornita agli avventori a questo scopo – mentre troneggiava mascheratissimo e immobile tra i suoi quadretti. Grazie per il prossimo film, gli dissi all’epoca del suo ottantesimo compleanno, sicuro che l’opera in questione esistesse già, girata e montata in quattro e quattr’otto, pochi giga salvati sul desktop.
Perché Rosa von Praunheim è importante ancora oggi? Perché lo è il messaggio che conclude il suo film più famoso: Raus aus den Toiletten! Rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen! Basta sostituire i cessi con internet e il gioco è fatto. Battere digitalmente non è peraltro la stessa cosa di battere in carne e ossa, in un cesso o in un parco, in un locale o per strada, con le antenne dritte e il corpo che tracima sfrontatezza. Il desiderio di libertà espresso dagli anni Settanta, con la sua grana grossa, ha ormai ceduto il passo a una normalizzazione dello stigma, o a una normalizzazione del far finta di niente. Siamo tutti avatar farlocchi, asessuati, invincibili. Oggi più che mai c’è bisogno di sana, concreta audacia senza tanti fronzoli. Rosa dovrebbe diventare il metodo vincente di un nuovo attivismo da contrapporre alle forze tiranniche, ipocrite, conservatrici o, peggio ancora, pavide e indifferenti. Da rosa, come il triangolo rosa, a grimaldello (come Dietrich, Marlene).
A pagina 11 di Sex und Karriere si conclude così il breve testo intitolato Nach dem Schwulenfilm, Dopo il film frocio – correva l’anno 1976: “Il film ha cinque anni, ma è più attuale e necessario che mai. In tutto questo tempo non è mai stato girato un film sui froci che avesse un carattere emancipatorio. Solo merda commerciale come Festa di compleanno per il caro amico Harold, autocommiserativa come Il diritto del più forte di Fassbinder, che a quanto pare è ambientato solo per caso nel mondo gay, migliaia di porno stupidotti o robaccia underground à la Warhol che concepisce i froci solo come delle strane creature. Il lavoro dei gruppi è andato scemando. In America le attività si sono via via spostate dalle grandi città alla campagna, il che è molto positivo. Da noi nascono vari gruppetti di breve durata, i vecchi scompaiono. Gli eroi sono stanchi ormai: la rivoluzione non diverte più nessuno (e non solo tra noi froci). Oggi non sarei più riuscito a realizzare questo film per la televisione, sarebbe stato vietato in quest’epoca conformista. A volte penso di fare un film commerciale: una storia d’amore tra due uomini che descriva il kitsch ma anche gli sforzi emancipatori. Per i quali bisogna attivarsi, altrimenti si perde il coraggio e la voglia di insistere. Perché il lavoro su sé stessi e gli altri è faticoso, e io stesso ultimamente me la sono presa comoda, ritirandomi nel mio illusorio mondo artistico. Già, io stesso soffro per la medesima situazione inumana, il sesso anonimo, la difficoltà nel trovare il partner giusto con cui scopare ma anche parlare, una persona che io possa accettare sul piano umano e intellettuale e viceversa. Un sogno?”
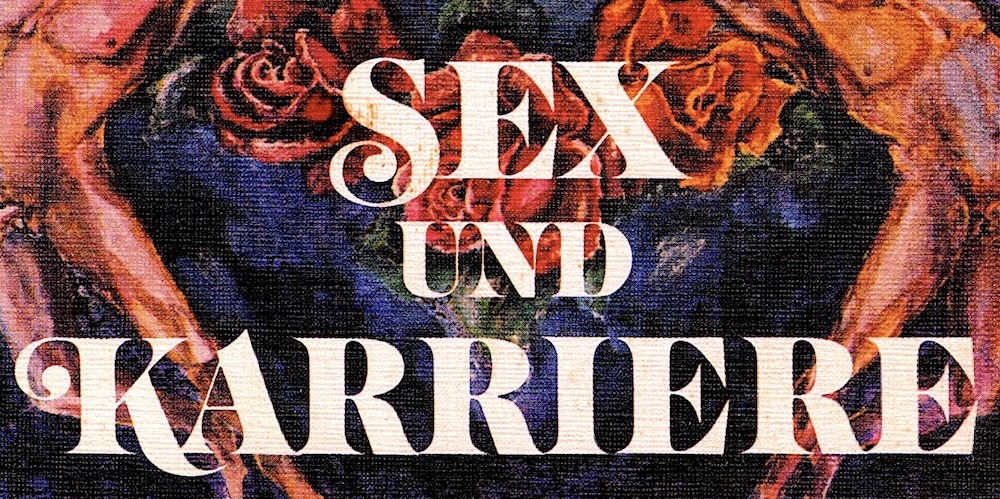


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.