
Siamo al Cairo, uno di quei luoghi che sono centro assoluto, conglomerato e messa a fuoco. Se Roma è un rarissimo esempio di capitale non solo politica ma anche storica, artistica e religiosa, il Cairo coi suoi quasi venti milioni di abitanti ci va molto vicino, ed è il classico esempio di città che non dorme mai. La chiusura dei negozi è misteriosa come il passaggio dei minibus, la notte è una stratificazione di suoni tra il codice Morse dei clacson, civette, cani & gatti, strepiti, preghiere, le sirene dei taxi sul Nilo e i fischi dei treni, identici al barrito dei tir. Di mattina si ode il “becchìa” itinerante dei robivecchi. Tutto scorre, soprattutto su sé stesso, attorno a un centro invisibile e ubiquo che trasuda la consapevolezza di essere arrivati a destinazione. È un perpetuum mobile che ingoia, rumina, sputa per terra dal motorino (sopra in quattro, bimbi compresi), riapre fauci ridenti e azzanna senza tante spiegazioni. Che altro c’è da dire? Siamo al Cairo.
Per la prima volta da quando vengo al Cairo, cioè dal febbraio 2020, siamo andati al cinema. Downtown sembra a tratti un cimitero di enormi teatri chiusi in attesa di un crollo spontaneo, con poster vecchi di anni e architetture che incutono timore. L’offerta non è grandissima. Molte romcom, pubblicizzate anche via cartellonistica mastodontica piazzata ai lati del traffico e a volte persino in faccia a chi guida, tabelloni lucenti aggrappati a cavalcavia e palazzoni erosi dalla sabbia – e un solo multisala d’essai, si chiama Zawya, dove l’altra sera abbiamo visto un documentario intitolato The Brink of Dreams, su un gruppo di ragazze che fanno teatro di strada nella cittadina copta di Barsha, governorato di Al-Minya, denunciando la pratica dei matrimoni combinati e delle spose bambine serrate in casa a cucinare e sfornar figli. Saletta abbastanza piena, classici quindici minuti di trailer pre-proiezione stavolta utilissimi visto che hanno sparato Hollywoodgate e Seeking Haven for Mr. Rambo, e all’uscita una fila chilometrica di giovani venuti fin lì per vedere Interstellar. Sì, il film mmerigano del duemilaquattordici. Ho visto giovani fare la fila anche per i selfie sotto il cartellone. E mi son detto: tu non sai nulla.
Zitto zitto buono buono, l’istituto italiano di cultura, con sede a Zamalek, ha una sala squisitamente anni Sessanta dove proiettano ogni tanto film gratuiti. A ridosso di Natale, e non a caso, siamo andati a vedere Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Francesco Rosi, adattamento prodotto dalla Rai che alterna momenti muffi a schiaffoni clamorosi. Pochi libri sanno spiegare, senza dover ricorrere a linee guida governative, cos’è un’area interna. E il film, girato nei luoghi di cui si parla a cominciare da Aliano (nella finzione-non-finzione, Gagliano), rende subito l’idea filtrando tutto con la faccia e il corpo di Gian Maria Volonté, eterno sinonimo del cinema di impegno civile, camaleonte degli accenti, ma anche controfigura di quel centro, di quella prospettiva centrale rispetto a cui i contadini lucani sono sfondo schiacciato e sfocato. I primi minuti dicono già tutto, con Carlo Levi reduce dal confino nel suo spazioso appartamento torinese decorato con i ritratti ancestrali degli abitanti di Gagliano, la promessa di tornare da loro rimasta lettera morta.
Mai come adesso c’è bisogno di cinema contadino. Guardando il film di Rosi, il castratore di maiali vagabondo dalla barba riccia, la faccia piena e il dialetto inintelligibile, guardando Irene Papas che fa la serva (improbabile), Alain Cuny barone in visita per raccogliere le tasse (probabilissimo), desiderando un ribaltamento delle proporzioni tra primo piano e sfondo, mi è venuto in mente che solo Alice Rohrwacher potrebbe rifare “Eboli” come si deve, cambiando la cifra stilistica ma non l’analisi sociologica presa dal romanzo, che spezza mitemente le reni al fascismo e legge il brigantaggio come una forma di resistenza legittima e necessaria. Una tesi, questa, che oggi farebbe squillare molte trombe populiste, per tacere di rapidi paragoni con le mafie, ma che dal punto di vista di un’area interna, abbandonata e precaria, usata allora come confino, oggi come non-meta turistica, paesaggio di passaggio, al massimo sacca da rapinare, sconvolgere, modernizzare e riabbandonare, una tesi, questa, che è semplicemente commisurata ai fatti. All’epoca, Mussolini preferiva creare l’impero in Africa che portare più Italia ai margini interni dell’Italia.
Cristo si è fermato a Eboli chiude degli anni Settanta prodigiosamente contadini, buon ultimo dopo il doppio Novecento di Bertolucci e la doppia Palma d’oro consecutiva per Padre padrone e L’albero degli zoccoli. I Taviani, ma soprattutto Olmi hanno cercato di mantenere vivo uno sguardo contadino sul mondo, sempre più raro, ridottosi nel corso dei decenni a barzelletta pieraccioniana, a Cascina Vianello. Ecco perché fin da Corpo celeste (2011) il lavoro di Rohrwacher ha qualcosa di miracoloso. Lazzaro felice (2018) riesce a parlare delle aree interne, degli sfruttamenti, del binomio ingenuità e crudeltà, di povertà e lavoro inutile, con una precisione inedita. Al suo meglio, Rohrwacher fonde neorealismo e cinema di impegno civile con le svirgolate geniali e favolistiche di Zavattini.
Tutt’altra strategia ma esiti analoghi in un libro edito da Piano B, Atlante Appennino – un’ecobiografia, di Elisa Veronesi. Se Rohrwacher non ha mai bisogno di note a piè di pagina e citazioni illuminanti, perché come Pasolini in Accattone sembra tutte le volte inventare il cinema di sana pianta, il volumetto di Veronesi ha il dono di un impianto accademico stemperato in pagine di narrativa pura, presa diretta col territorio e chi ci vive. L’autrice parla del proprio percorso biografico di nativa dell’Appennino Reggiano emigrata in Francia, cita Timothy Morton, Latour, Didi-Huberman, Butor e Nietzsche, Sbarbaro e D’Arzo, tutto fa fuorché fornire letteralmente un atlante appenninico, ma quello che fa, e che tenta di fare da anni Matteo Meschiari (ampiamente citato) è dare voce all’Appennino, questa fragile spina dorsale che attraversa l’Italia dalla linea Spezia-Rimini fino alla Sicilia, passando proprio per Aliano.
Il dramma appenninico non è solo di servizi carenti e abbandono, come la metterebbe Fabrizio Barca, ma anche di lingua e racconto. Non si sa che cos’è. Mancano i punti fermi, l’epica pervasiva del centro. E come tutte le aree interne, invece di fare gradualmente egemonia verso i centri, è il centro a filtrare capillarmente nella periferia, a dominarla con loghi e prodotti, Coche Cole e algidi gelati industriali, soprattutto coi telefonini e le solite app. Mai vittoria del centro è stata più evidente come l’onnipresenza degli smartphone, il loro effetto zombificante, poco importa se sia l’Appennino, Barsha o la Cisgiordania. Scrive Elisa Veronesi a pagina 79 di Atlante Appennino: “Una certa uniformità geologica e botanica caratterizza quella catena montuosa che chiamiamo Appennino Settentrionale, in particolare quello che si estende da Bologna a Piacenza, e che si differenzia per conformità da Alpi, pianura e zone costiere in un suo specifico genius loci che, tuttavia, permane refrattario a narrazioni e storie in grado di creare un immaginario radicato, una mitologia appenninica del racconto. Incominciare a costruire un immaginario a partire dal luogo, dalla terra, dall’arenaria, dai sentieri, senza utilizzo di sfondi, ma ritrovando i gesti degli uomini incistati nel legno, nel campo, nel gregge, nella casa. Mi rigiro tra memorie sparse e del tutto anacronistiche di quell’Appennino nel quale sono nata e cresciuta, luogo anagrafico e biografico che diventa luogo di memorie plurime e indistinte; provando a reperirne i territori, e lasciando che piano piano la vita si scriva insieme e attraverso quella dei luoghi. Innestare l’oikos nel bios, renderlo di nuovo visibile, bucare l’isolamento. Un’eco-auto-bio-grafia che provi a ri(n)tracciare un paesaggio del quale facciamo parte, tutti, nell’ipotesi che il paesaggio concreto abbia funzionato, e per qualcuno funzioni ancora, come una specie di laboratorio naturale per inventare delle logiche alternative [Matteo Meschiari, Geoanarchia. Appunti di resistenza ecologica, Armillaria, 2017, p. 79]”.
Rischiando l’eresia data la delicatezza del tema, chiudo questa orecchia e quattro anni consecutivi di orecchie con un’altra area interna: la Cisgiordania. Lo faccio sulla scorta di un documentario che andrebbe proiettato ovunque, sulle facciate delle case e sulla fronte delle persone sorde, soprattutto in Germania, dove un giornalismo acritico e una politica dogmatica e senza coraggio né fantasia stanno facendo danni enormi. No Other Land è un lavoro collettivo trainato dall’attivismo di Basel Adra. Siamo a Masafer Yatta, puntini nel paesaggio sparpagliati lungo il confine dei territori palestinesi. Puntini nel mirino dell’IDF e dei coloni, che vi fanno regolarmente visita armati di ordini di demolizione, bulldozer e fantascientifica attrezzatura bellica allo scopo di creare zone di addestramento militare. Il film racconta tre anni di angherie e occupazioni territoriali senza senso, se non quello di sfasciare case, cessi e recinti di animali da reddito, costringendo gli abitanti del villaggio a vivere nelle caverne – manco tutelate dall’Unesco come i sassi di Matera. Non ci vuole Lucio Caracciolo per capire che la prepotenza, spesso gratuitamente assassina, dell’esercito israeliano e dei suoi coloni arrembanti abbia l’unica finalità di conquistare territorio e costringere la popolazione palestinese lontano dalle aree interne, da casa loro, gonfiando città come Hebron fino ai limiti estremi. E concentrare significa anche rendere visibili in un solo mirino.
Adam Kirsch, in On Settler Colonialism – Ideology, Violence and Justice (2024), saggetto delirante consigliato dal New York Times, ha il coraggio di affermare che il dramma palestinese non esiste per il semplice motivo che nelle città dei territori la popolazione – al netto delle vittime di guerra – è in crescita costante. Ora, se da un lato è inaccettabile qualsiasi paragone col nazismo, così come qualsiasi slogan che sottintenda la scomparsa di Israele, dall’altro è incredibile il livello di disumanizzazione del popolo palestinese cavalcato tra urletti e schiocchi di frustino da buona parte dei media che chiamiamo occidentali. Il terrorismo c’è, ma se parliamo di vite e famiglie, ci sono soprattutto sofferenza e dislocazione. E in Cisgiordania, per parlare solo della Cisgiordania, c’è il doppio dramma delle aree interne lasciate a sé stesse e predate da esercito e coloni.
Il germe di No Other Land è un video montato nel finale, drammaticamente notissimo grazie a internet, ma è il corpo ibrido del film, le sue inquadrature spontaneamente efficaci, l’equilibrio tra il senza filtro e la poesia della quotidianità, con una moderata dose di postproduzione, a renderlo non solo un documento importante, ma anche un esempio di come le aree interne possano parlare da sé, prendendo in prestito gli strumenti del centro – la tecnica, la viralità – e trasformando il dialettale in universale, l’esotico incomprensibile in materiale del tutto relatable. Non sono loro, siamo noi. Tra le righe del documentario c’è anche la storia d’amore, irraccontabile ma palese, tra Basel e l’israeliano Yuval, l’attivista e l’alleato. Irraccontabile anche perché con i suoi 95 minuti il film è già troppo pieno, sembra chiedere lui stesso spazio vitale e un po’ di pace. Senza Yuval, che dimostra come non tutti in Israele seguano ciecamente la propaganda governativa, il film sarebbe monco e darebbe il fianco alle solite critiche. Nel frattempo, Masafer Yatta sta scomparendo.
Il momento forse più atroce di Cristo si è fermato a Eboli nella versione di Rosi è una diretta radiofonica in cui Mussolini legge il telegramma di Badoglio da Addis Abeba. Le immagini mostrano una carrellata di lavoro nei campi immobilizzato nell’ascolto (piano sequenza qui, da 32:20). In seguito a questa conquista coloniale datata 5 maggio 1936 anche Carlo Levi viene esonerato dal confino, e può tornare in Piemonte. “Annuncio al popolo italiano e al mondo”, tuona il lungimirante uomo solo al comando, “che la guerra è finita”.


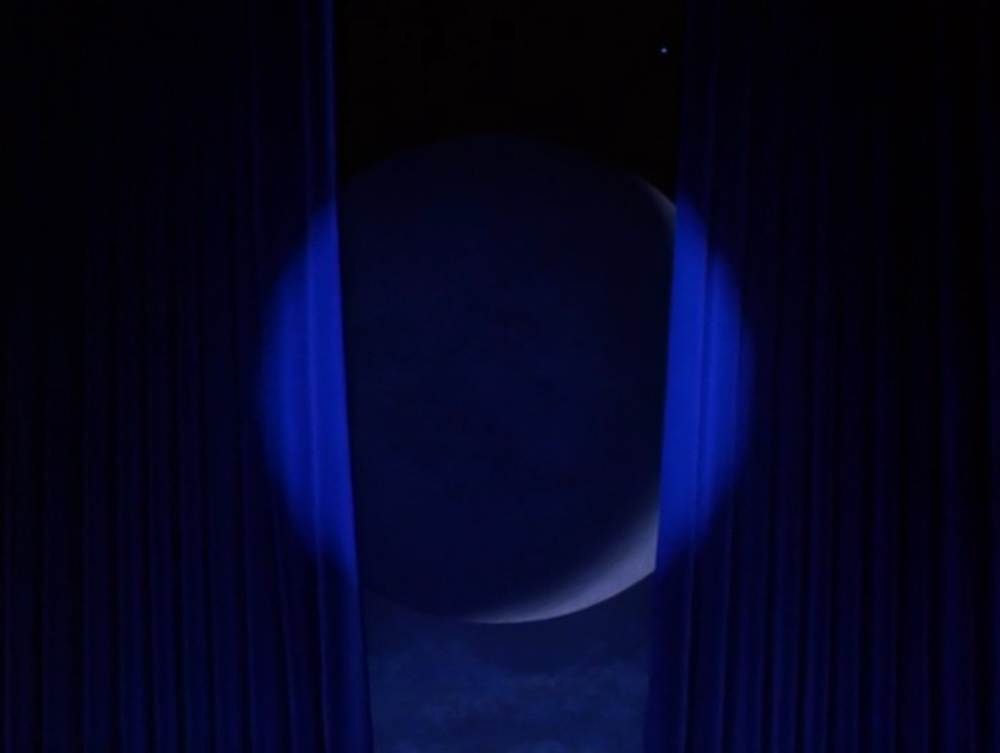
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.