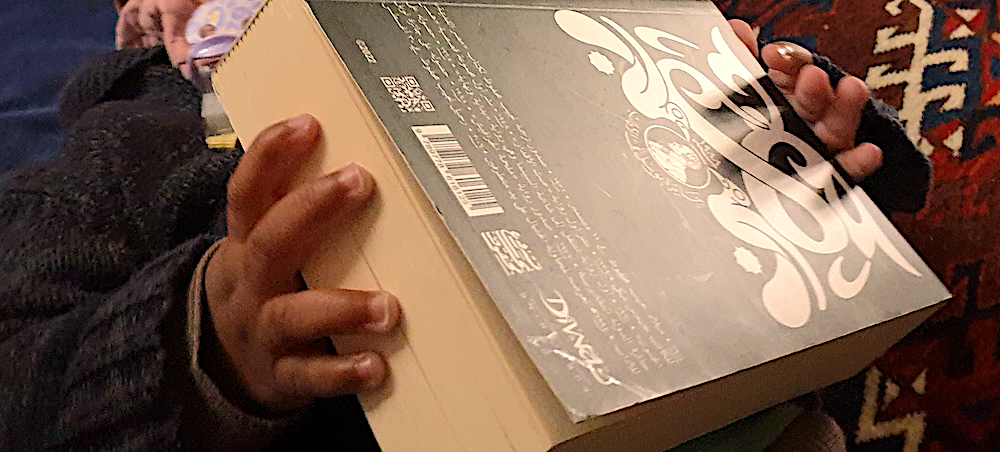
Chiamatemi Dedda. Dev’essere successo in giugno, cioè trilioni di anni fa, quando Yassien mi disse che nostro figlio mi chiamava Dedda. Pensai prima a un’ipotesi fragile e affettuosa, poi a un caso di polisemia omofona, poi ebbi davvero il sospetto che Elia mi chiamasse, come mi chiama ancora, Dedda. Spesso sovrappensiero, giocando col ciuccio, quasi a dire quel tonto di Dedda, che robe che fa. A volte si canta da solo una didda dadda (dedda). Decisione filiale, insindacabile, come quella di chiamare Yassien Bebè. Quindi il babbo è Dedda, il papà è Bebè. E PucciPatati è PucciPatati è PucciPatati.
Trilioni di anni fa eravamo ancora nel socialismo, in un Plattenbau, con un bimbo koala che schizzava sul laminato muovendosi a foca sul dorso per la disperazione della fisioterapeuta, convinta che senza il passaggio del gattonamento Elia sarebbe cresciuto male, idiosincratico, con una rotella di meno. E ora? Ora siamo per la prima volta in una città città, che potrebbe essere Berlino ma chiamiamo Neukölln, con nessuna voglia di uscire dai suoi lontani confini. In casa, alla larga dalla botola che porta in cantina, c’è un bimbo koala che schizza sulle tavole di legno gattonando alla grandissima, urlettando quando si sente inseguito, con una voglia matta di sballottare tavolini, distruggere vasi, abbattere router e afferrare dizionari dal peso medio di un chilo. Le prese son già tutte tappate, ma i cavi abbondano e non c’è nulla di più indianagiòno che tirarli sperando di portarsi dietro una lampada o di assaggiare questi meravigliosi spinotti voluti dalla UE. Ma anche in questo mondo di avventura ci sono delle costanti introdotte ai tempi del socialismo e degli pterodattili, ad esempio il cane parlante Fisher Price dalle orecchie blu che ogni tanto canticchia con voce femminile: “Dov’è il pollice / dov’è il pollice / Eccolo qua / Eccolo qua / Come sta signore / Molto bene grazie / Vado via / Vengo anch’io”. Il costruttore s’è scordato il no tu no.
L’ode che non ho mai levato a Kreuzberg e Friedrichshain potrei scriverla adesso per Neukölln, questo universo autonomo e vispo al quale, in quasi vent’anni, non avrei dato tre copeche. Al massimo due. E ora mi chiedo, ma cosa ho fatto prima, perché ho aspettato tanto, come ho potuto essere così cieco? Già la Hermannstr. che porta a casa è una marcia trionfale di falafel sottocosto, insegne lovecraftiane, manieri abbandonati e cimiteri apollinei. Per tacer dei figuri che la popolano, categoria a cui apparteniamo anche noi, felici come pasque con la borsa della spesa e il dottor Koala nel marsupio. Ogni parallela è un mondo a sé, con cantonate hipster ben temperate dal classico spirito berlinese grezzo e solidale, rimasto intatto in anfratti sempre più angusti. Qui le proporzioni, rispetto ai Bezirke di cui sopra, sembrano invertite. Il gentrificato arranca, la spesa all’Hermann Quartier è un’esperienza antropologica che sa ancora di Novecento. Grazie anfratti intatti, grazie Stadtbild così avversato da quel pisquano di Merz.
A un tiro di schioppo, il Feld, che Vincenzo Latronico ha chiamato “quattro chilometri quadrati di potenziale puro”. C’è tanto di quel cielo, sull’ex aeroporto ora parco pubblico (finché dura), che spesso bisogna cambiare direzione per non lasciarsi accecare dal sole. Attraversandolo in bici si potrebbe chiudere gli occhi e staccare le mani dal manubrio per cinque minuti buoni. Ovvio, è una palla. Ma è il potenziale puro a sussurrartelo all’orecchio ogni volta, aggiungendo altro che cinque, dieci minuti, un quarto d’ora, chiudi gli occhi, spalanca le braccia, allarga l’inquadratura fino al Cinemascope! Il Feld è un tale concentrato di benessere cittadino che ogni volta che son lì, sotto una volta sconfinata di cielo terso, mi vien da pensare, vuoi vedere che adesso a Friedrichshain piove?
Elia gattona, Elia mangia pasta coi friarielli, Elia c’ha un gruppuscolo di denti acuminati come rasoi da lavare con un bellissimo spazzolino piccolino. Elia dorme. Ma come, ma quando? La storia di questi ultimi mesi/millenni è anche una storia dei preferiti di Spotify, messi scientificamente alla prova di un koala non sempre prontissimo a ronfare della grossa dopo qualche passo di danza col babbo. La (ri)scoperta più clamorosa è stata Mike Oldfield. Con Moonlight Shadow, almeno in due occasioni Pupi è partito alla volta dei sogni belli prima ancora che finissero i tre minuti e quaranta del pezzo. Anche To France funziona bene, oltre a essere un’ulteriore madeleine per noi bùmer cresciuti a Mulino Bianco e Drive In. I primi minuti di Tubular Bells, per intenderci la colonna sonora dell’Esorcista, sono musica perfetta per cullare: ripetitiva, avvolgente, birbante. Chissà a cosa pensa Elia mentre la sente, lui che conosce solo l’Esorciccio (“Se non ti addormenti entro le 21 chiamo l’Esorciccio”, adagio paterno). Altri pezzi in rotazione pesante quando il giuoco si fa duro: Breathe di The Silent League, Enjoy the Silence (di sapete benissimo chi), Decks Dark dei Radiohead, Neon & Ghost Signs dei Rialto, cioè dell’aristocratico Louis Eliot redivivo dopo quasi un quarto di secolo. E poi c’è Hoppípolla dei Sigur Rós, che sembra scritta per lui, quell’Hoppípolla di un bimbo Hoppípolla. Quando parte è un inno alla gioia che potrebbe annunciare qualsiasi cosa, anche la pace nel mondo. Noi qua siam gente semplice e pratica, ci accontentiamo di un inno a Elia cantato in hopelandic maccheronico da un dedda e da un bebé.




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.